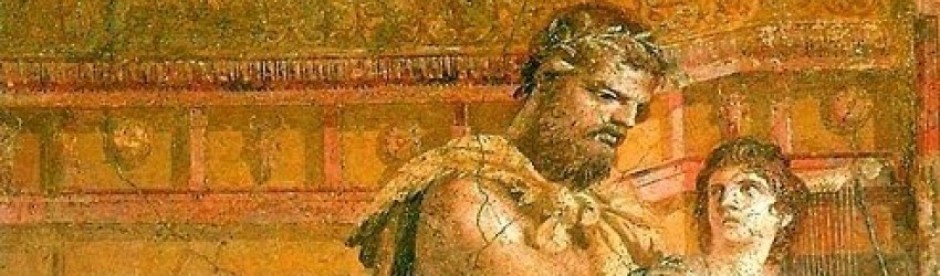Suave, mari magno turbantibus aequora ventis
e terra magnum alterius spectare laborem;
non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,
sed quibus ipse malis careas quia cernere suavest.
Suave etiam belli certamina magna tueri
per campos instructa tua sine parte pericli.
L’uomo conduce la sua vita ed erige le sue istituzioni sulla terraferma. Ma il movimento della propria esistenza cerca di comprenderlo, nella sua totalità, specialmente con la metafora del temerario vagare. Il repertorio di questa metaforica nautica dell’esistenza è ricco. Ci sono coste e isole, porti e alto mare, scogliere e tempeste, secche e bonacce, vele e timoni, timonieri e ancoraggi, bussola e navigazione astronomica, fari e piloti. Spesso la presentazione dei pericoli del mare aperto serve semplicemente a far vedere la comodità e la calma, la sicurezza e la serenità del porto dove il navigare deve trovare la sua conclusione. Solo dove il raggiungimento di una meta deve restare escluso, come negli scettici e negli epicurei, la stessa bonaccia in alto mare può stare per la visione della pura felicità. […]
In quest’ambito immaginativo il naufragio è una specie di «legittima» conseguenza della navigazione, mentre il porto felicemente raggiunto o la calma di mare sono soltanto l’aspetto ingannevole di una così radicale problematicità. Ma la contrapposizione tra la terraferma e il mare incostante, se la si prende come schema guida per il paradosso della metaforica dell’esistenza, fa supporre che debba esserci – come rafforzamento delle immagini di navigazione e naufragio – anche quella configurazione per così dire intensiva, dove al naufragio in mare viene associato lo spettatore non coinvolto sulla terraferma. La letteratura, vorrei dirlo con un enunciato a priori, non poteva non cogliere questa convergenza; la quale a sua volta non poteva mancare lo scandalo, quando introdusse l’imperturbato spettatore come il tipo che […] si sente appagato, o addirittura ne gode. […]
La configurazione è stata creata dal romano Lucrezio. Il secondo libro del suo poema cosmico esordisce con l’immaginazione di osservare dalla salda riva il travaglio dell’altro sul mare agitato dalla tempesta: «…e terra magnum alterius spectare laborem». La gradevolezza dello spettacolo non sta certo nelle pene di un altro, ma nel fatto di godere il proprio imperturbabile punto di vista. Non è affatto questione di un rapporto tra uomini, quello che soffre e quello che non soffre, ma del rapporto del filosofo con la realtà: il tema è l’utile della filosofia di Epicuro, il possesso di un terreno saldo e inattaccabile dal quale guardare il mondo. Anche lo spettatore di immani battaglie, che però è al sicuro dai pericoli della guerra, deve semplicemente esemplificare il divario tra il bisogno di felicità e la caparbietà inflessibile della realtà fisica. Solo l’assicurazione filosofica dello spettatore può mitigare in distanza questo divario. È il saggio […] che nella figurazione dello spettatore porta a compimento l’ideale di teoria della filosofia greca classica, ma anche che in un punto decisivo gli si oppone.
L’opposizione significa: lo spettatore gode non della sublimità degli oggetti che la sua teoria gli dischiude, ma della consapevolezza di sé di fronte al turbine di atomi di cui consiste tutto ciò che egli osserva – perfino lui stesso. Il cosmo non è più l’ordine la cui visione colma di eudemonia [felicità] chi lo contempla. È tutt’al più la garanzia residua che c’è un terreno solido al quale l’elemento ostile non arriva. Significativo a questo riguardo è non solo il fatto che Epicuro è greco e Lucrezio romano, ma che tra di essi corrono due secoli. L’indifferenza della teoria si è data lo stesso rango e potere, si è messa all’altezza dell’indifferenza della realtà rispetto alla sua particella uomo.
Come d’altronde nel saggio di Epicuro e di Lucrezio si incarna qualcosa dell’immagine dei loro dei, situati al di fuori dei mondi, e che è come se fossero passati per la filosofia. Essi possono essere beati, come si dice che siano, solo perché non sono né i creatori né gli amministratori dell’accadere del mondo, e si dedicano interamente a se stessi. Lo spettatore del mondo non è capace di essere così puro. Per poter consolidare il proprio modesto esser-quasi-fuori-del-mondo, gli occorre almeno la fisica degli atomi. Vero spettacolo potrebbe essere solo un dio; ma un dio non vuole nemmeno questo. […]
Ricorrendo ancora una volta alla metafora del pericolo in mare e del naufragio, coerentemente Lucrezio parla del proprio universo di moti disordinati degli atomi come dell’oceano della materia («pelagus materiae»), da dove le forme della natura, quasi rottami di grandi naufragi («quasi naufragiis magnis multisque coortis»), vengono scagliate sulla riva dell’apparenza visibile, indizi ammonitori ai mortali della perfidia del mare. Solo perché la scorta di atomi è inesauribile, le catastrofi della realtà fisica possono restare feconde di configurazioni, e generare per l’uomo che sta sulla riva la facciata di una certa regolarità. È chiaro cosa significhi qui lo indicium mortalibus: l’uomo fa bene ad accontentarsi della parte di spettatore e a non abbandonare la propria posizione filosofica di fronte e al di sopra del mondo della natura. Dall’identità di catastrofe e produttività in questa teoria di un universo in divenire e in dissoluzione, come individuo egli non può trarre alcun profitto.
H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, Il Mulino, Bologna, 2001

Sarcofago marmoreo, III sec. d. C., Carlsberg Glyptotek di Copenaghen
Il topos del “naufragio con spettatore”
Il secondo libro del De rerum natura di Lucrezio si apre con un’immagine potente: poggiando sulla terraferma, uno spettatore contempla il travaglio di un naufragio. Non partecipa agli eventi; gode soltanto della visione che ha dinanzi.
La sua non è una iocunda voluptas, sorta immediatamente dalle tribolazioni altrui, verso cui guarda anzi con commosso distacco. La serena gioia che lo pervade scaturisce dal confronto fra la sicurezza della sua posizione e il pericolo e la rovina degli altri.
L’immagine lucreziana non è che un’allegoria del saggio epicureo. Questi, simile agli imperturbabili dèi degli atomi, l’infinito gioco della combinazione e della dissoluzione delle forme. Il suo solido terreno è la filosofia di Epicuro, che insegna a vivere senza paure e superstizioni in un universo indifferente alla sorte degli uomini. Il mare in tempesta è invece l’intera natura, di cui anche le società umane sono parte. Essa è il frutto di una incessante lotta tra gli elementi, dove il nuovo si genera dal vecchio, servendosi della sua materia e delle sue forme come di rottami di grandi naufragi.
In se stesso lo spettacolo non ha niente di gradevole: la natura non è un cosmo, un ordine, in cui ci si senta spontaneamente a proprio agio, a casa.
Presenta semmai un aspetto ostile, terribile. Epicuro e Lucrezio cancellano la linea di demarcazione aristotelica tra il «cosmo superiore», perfettamente ordinato e retto da una finalità non ostacolata, e il mondo sublunare in cui ordine e finalità prevalgono di norma, con fatica, sul disordine e il caso. Tutto l’universo lucreziano è lacerato dalle vicissitudini di un ordine labile che sorge dal caso, che si genera e si disintegra continuamente, senza scopo, nello spazio e nel tempo infiniti. Il saggio è colui che sa sottrarsi a tale gioco alterno di creazione e di distruzione; che, di fronte ad esso, mantiene ed ostenta la propria costanza, imperturbabilità e serenità. La sua grandezza, il suo dominio sulle tempeste ed i naufragi del mondo, non consiste tanto nella superiorità dell’intelletto, quanto nella forza dell’animo. Ma essa, a sua volta, dipende dall’esercizio della teoria, e cioè, letteralmente, dall’abitudine a contemplare uno spettacolo (è questo uno dei sensi più antichi e pregnanti del verbo theorein): lo spettacolo quotidiano di vita e di morte che la natura mette in scena. Un intrattenimento infinito, privo di epilogo, in cui nessuno degli avversari in lotta consegue una vittoria definitiva: «Così i motivi rovinosi non possono prevalere/ per sempre e seppellire in eterno la possibilità di esistenza,/ né i moti che generano e producono l’accrescersi delle cose/ possono conservare in perpetuo ciò che hanno creato./ Si svolge così con incerta contesa degli elementi/ primordiali una guerra ingaggiata da tempo infinito./ In luoghi e in momenti diversi trionfano i germi vitali dei corpi,/ e a vicenda soccombono. Si mischiano pianti di morte/ e vagiti levati da fanciulli che vedono le rive della luce;/ una notte non segue a un giorno, né un alba a una notte,/ che non abbia ascoltato, confusi con tristi vagiti,/ lamenti compagni di morte e di funebri esequie» (II, 569-580).
Hans Blumenberg analizza esemplarmente l’immagine lucreziana del «naufragio con spettatore» e ne traccia la parabola attraverso le elaborazioni e le variazioni che si susseguono numerose nell’arco di due millenni. […] La svolta più netta rispetto alla tradizione esemplificata da Lucrezio si manifesta con Pascal ed avviene nel quadro della «rivoluzione copernicana». La filosofia di Pascal non consente più di tirarsi fuori dallo spettacolo del naufragio, si stare semplicemente ad osservare sulla riva. Vous êtes embarqué [«voi siete a bordo della nave»]: si è da sempre in una situazione rischiosa, in mare, in pericolo.
Non si danno certezze assolute, ma solo probabilità, più o meno elevate, più o meno soggettivamente attendibili. Per questo motivo il comportamento razionale non coincide con l’aggiornamento di rischi comunque inevitabili, con il privilegiamento dell’inerzia di chi è disposto a contentarsi di poco, ma con l’accettazione di una scommessa, la più alta. Si salva, probabilmente, non chi contempla la rovina altrui, ma chi soffre e spera – secondo l’insegnamento del Vangelo – assieme agli altri, chi considera fattivamente gli uomini non come individui lontani e indifferenti, bensì come «prossimi» e fratelli. Bisogna, dice Pascal, riconoscere la precarietà, l’elemento “marino”, come il nostro ambiente naturale: «Noi voghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all’altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci e di fissarci vacilla e ci lascia; e, se lo seguiamo, ci si sottrae, scorre via e fugge in un’eterna fuga. Nulla si ferma per noi. È questo lo stato che ci è naturale e che, tuttavia, è più contrario alle nostre inclinazioni. Noi bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile e un’ultima base sicura per edificare una torre che si innalzi all’infinito; ma ogni altro fondamento scricchiola e la terra si apre sino agli abissi». Non esiste più un luogo assolutamente sicuro in un universo che ha perduto il suo centro, in una Terra che è una «prigione» buia e periferica.
Non si trovano più né punti di vista privilegiati e fissi per spettatori sereni e imperturbabili, né teorie che possano poggiare cartesianamente su una base incrollabile, un fundamentum inconcussum. Cade la differenza fra terra e mare: anche la terra vacilla e spalanca i suoi abissi. Si potrebbe paradossalmente “naufragare” sulla terra non più ferma. Il pathos di Pascal è forzatamente diretto verso la mobilità, l’incertezza, il rischio a cui ogni esistenza e ogni pensiero sono esposti. Lo spettatore è costretto a diventare attore, a mettere in gioco se stesso, a rischiare il naufragio. La buona coscienza è ormai negata a colui che guarda dall’esterno i mali del mondo. Solamente una speranza rischiosa, una scommessa, viene lasciata in cambio all’umanità sofferente.
R. Bodei, Introduzione a H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 7-13 passim
APPROFONDIMENTO. Il mare: fascino e terrore, dall’antichità ad oggi.