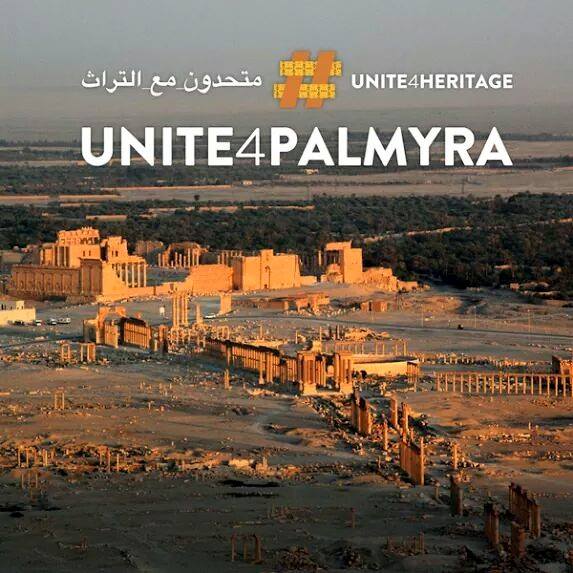ILIADE, Libro XXIV. Traduzione di M. G. Ciani
Si sciolse l’assemblea e si dispersero gli uomini verso le navi veloci; pensavano con gioia alla dolcezza del cibo e del sonno. Ma Achille piangeva pensando all’amico, non cedeva al sonno onnipotente, e non aveva requie rimpiangendo Patroclo, la sua forza, il suo nobile ardore, ricordando le molte pene che avevano patito insieme nelle battaglie degli uomini o sulle acque crudeli del mare; ricordava e versava lacrime fitte, stando disteso ora su un fianco, ora supino, ora bocconi; a volte si alzava e andava errando, smarrito, lungo la riva del mare; ma non appena sorgeva l’alba, sul mare e sulla riva, allora aggiogava al carro i cavalli veloci e dietro attaccava Ettore per trascinarlo: tre volte lo trascinava intorno alla tomba del figlio di Menezio, poi ritornava nella sua tenda e lasciava il cadavere nella polvere con la faccia contro la terra.
Ma dell’eroe morto Apollo aveva pietà e dall’oltraggio difendeva il suo corpo, coprendolo con l’egida d’oro perché Achille, nel trascinarlo, non gli scorticasse la pelle.
Così, nel suo furore, Achille oltraggiava il corpo di Ettore glorioso; ma gli dei beati, vedendolo, furono mossi a pietà ed esortavano Hermes, il dio dall’occhio acuto, perché rapisse il cadavere. Acconsentivano tutti gli dei, ma non Era né Poseidone né Atena dagli occhi lucenti; come prima, essi odiavano la sacra città di Ilio, odiavano Priamo con tutto il suo popolo per la follia di Alessandro che osò insultare le dee: quando si recarono infatti al recinto dove sorvegliava il bestiame, egli scelse colei che gli fece dono della lussuria funesta.
[…]
Disse così e acconsentì la dea dai piedi d’argento, dalle vette dell’Olimpo scese di slancio e giunse alla tenda del figlio; lo trovò che piangeva a dirotto mentre intorno i compagni si affaccendavano a preparare il cibo; sacrificavano anche un ariete, grande e lanoso, là, nella tenda. Si sedette accanto all’eroe la nobile madre, lo accarezzò con la mano e chiamandolo per nome gli disse:
«Figlio mio, fino a quando ti consumerai nel dolore e nel pianto, senza pensare né al cibo né ai piaceri del letto? E bello unirsi a una donna, in amore; e tu non vivrai a lungo, già ti è vicina la morte, il destino inesorabile. Ma ora prestami ascolto, io vengo a te messaggera di Zeus: ti manda a dire che tutti gli dei sono in collera e lui stesso più di tutti è adirato perché tu con animo folle trattieni Ettore presso le concave navi e non vuoi restituirlo; rendilo, dunque, e del suo corpo accetta il riscatto».
A lei rispose l’eroe dai piedi veloci:
«E sia! Chi porterà il riscatto si porterà via il corpo, se è la mente saggia di Zeus che ordina e impone».
[…]
Dopo aver detto queste parole, tornò al vasto Olimpo il dio Hermes. E Priamo scese a terra dal carro, lasciò Ideo a sorvegliare muli e cavalli e si diresse alla tenda dove sedeva Achille, amato da Zeus; lo trovò che era solo, stavano in disparte i compagni: due di loro soltanto, l’eroe Automedonte ed Alcimo, stirpe di Ares, gli si affaccendavano intorno; egli aveva appena finito di mangiare e di bere; la tavola era ancora apparecchiata. Entrò il gran re, senza essere visto, e quando fu accanto ad Achille gli abbracciò le ginocchia e gli baciò le mani, le mani terribili che tanti figli gli avevano ucciso. Come quando un’acuta follia travolge un uomo, che in patria ha commesso omicidio e si rifugia in terra straniera, nella casa di un uomo ricco, e coloro che lo vedono restano attoniti; così Achille restò stupefatto nel vedere Priamo simile a un dio; stupirono tutti, guardandosi gli uni con gli altri; e Priamo si rivolse a lui con parole di supplica:
«Ricordati di tuo padre, divino Achille, tuo padre che ha la mia stessa età ed è alle soglie della triste vecchiaia; e quelli che vivono intorno forse lo insidiano e non c’è chi lo difenda dalla sventura e dalla rovina. Ma lui, almeno, si rallegra in cuor suo sentendo che tu sei vivo, e di giorno in giorno spera di rivedere suo figlio di ritorno da Troia. Ma la mia sventura è immensa: ho messo al mondo valorosi figli nella grande città di Troia e di loro non me n’è rimasto nessuno; cinquanta ne avevo, quando giunsero i figli dei Danai; diciannove erano figli di una sola madre, gli altri nacquero da altre donne nella mia reggia; a molti di loro Ares ardente ha tolto la vita; l’unico che mi restava, colui che proteggeva la città e i cittadini – Ettore – tu l’hai ucciso mentre difendeva la patria; è per lui che io vengo ora alle navi dei Danai, per riscattarlo, e porto doni infiniti. Abbi rispetto degli dei, Achille, e abbi pietà di me, ricordando tuo padre; io sono ancora più sventurato, io che ho osato – come nessun altro fra i mortali su questa terra – portare alle labbra le mani dell’uomo che ha ucciso mio figlio».
Così parlò Priamo, e in Achille fece sorgere il desiderio di piangere per suo padre; prese il vecchio per mano e lo scostò da sé, dolcemente; tutti e due ricordavano: Priamo, ai piedi di Achille, piangeva per Ettore uccisore di uomini, e Achille piangeva per suo padre e piangeva anche per Patroclo: alto si levava, dentro la tenda, il lamento.
Ma quando Achille glorioso fu sazio di lacrime, quando il desiderio di pianto abbandonò le sue membra e il suo cuore, allora si levò dal seggio, prese il vecchio per mano e lo fece alzare; e compiangendo i capelli bianchi e la bianca barba del vecchio, si rivolse a lui con queste parole:
«Infelice, quante sventure hai patito nell’animo; come hai osato venire alle navi dei Danai, da solo, presentarti agli occhi dell’uomo che ti ha ucciso tanti figli valenti? Hai un cuore di ferro. Ma ora siedi su questo seggio, chiudiamo nell’animo, per quanto sia grande, la nostra angoscia; a nulla servono pianti e lamenti: hanno stabilito gli dei che gli infelici mortali vivano nel dolore, mentre loro non conoscono affanni. Nella dimora di Zeus vi sono due grandi orci che ci dispensano l’uno i mali, l’altro i beni; li mescola il dio delle folgori, e colui a cui ne fa dono riceve ora un male ora un bene; e chi riceve dolori diventa un miserabile, una insaziabile fame lo spinge per tutta la terra e lui va errando, disprezzato dagli dei, odiato dagli uomini. Ecco: gli dei diedero a Peleo splendidi doni fin dalla nascita; era superiore a tutti gli uomini per ricchezza e fortuna, era re dei Mirmidoni, e benché fosse mortale gli diedero come sposa una dea; ma poi gli inflissero anche una sventura, perché nel suo palazzo non sono nati figli destinati a regnare, un solo figlio è nato, dal breve destino; e io non sono lì per aver cura di lui nella sua vecchiaia, sono qui a Troia, molto lontano dalla mia patria, sono qui per la rovina tua e dei tuoi figli. E anche tu, vecchio, lo sappiamo, eri felice un tempo: nella terra racchiusa fra Lesbo, sede di Macaro, la Frigia e il vasto Ellesponto, eri superiore a tutti, per la tua ricchezza, per i tuoi figli; ma poi gli dei celesti ti hanno inflitto questo dolore, di vedere intorno alla tua città battaglie e carneficine. Fatti forza e non tormentarti senza tregua nell’animo; a nulla ti servirà piangere su tuo figlio, non lo farai rivivere e forse dovrai patire qualche altra sciagura».
Gli disse allora il vecchio re Priamo simile a un dio:
«Non farmi sedere, prediletto da Zeus, fino a che Ettore giace nella tenda, insepolto, ridammelo presto, che io lo veda con i miei occhi; e tu accetta i doni che ti ho portato in gran quantità; che tu possa goderne e possa tornare nella tua terra, tu che mi hai lasciato vivere e vedere la luce del sole».
Lo guardò irritato e rispose Achille dai piedi veloci:
«Non provocarmi, ora, vecchio; so che devo ridarti il corpo di Ettore, è venuto a dirmelo un messaggero di Zeus, mia madre, colei che mi ha dato la vita, la figlia del vecchio dio del mare. E so anche, Priamo, so bene che è stato un dio a guidarti fino alle navi veloci dei Danai; nessun uomo mortale oserebbe venire al nostro campo, neppure se giovane e vigoroso; non sfuggirebbe alle guardie e non smuoverebbe facilmente la sbarra della mia porta. Non provocare, dunque, il mio animo che soffre o non ti lascerò rimanere nella mia tenda, vecchio, anche se sei un supplice, e trasgredirò così il volere di Zeus».
Così disse, e il vecchio tremò di paura e obbedì al comando.
Come un leone intanto il figlio di Peleo si era slanciato fuori dalla porta; non era solo, lo seguivano due scudieri, il guerriero Automedonte ed Alcimo: dopo la morte di Patroclo erano quelli che Achille amava di più tra i suoi compagni; essi staccarono dal giogo i muli e i cavalli, fecero entrare l’araldo del vecchio e lo fecero sedere; tolsero dal carro ben lavorato l’immenso riscatto per il corpo di Ettore; ma lasciarono due teli di lino e una tunica dal fine tessuto per avvolgere il corpo quando Achille lo avesse restituito perché lo riportassero a casa. E l’eroe chiamò le schiave e ordinò che lavassero e poi ungessero d’olio il cadavere, ma prima lo fece portare lontano perché Priamo non lo vedesse, e vedendolo, per il dolore, non riuscisse a trattenere la collera ed egli allora non si irritasse al punto di ucciderlo, trasgredendo così il volere di Zeus. Lavarono il corpo e lo unsero d’olio le schiave, poi lo vestirono con la tunica e nel telo splendente lo avvolsero; Achille stesso lo sollevò e lo depose sul letto funebre; i compagni lo misero poi sul carro ben fatto. E Achille pianse chiamando per nome l’amico:
«Non adirarti con me, Patroclo, se nel regno di Ade verrai a sapere che ho restituito il valoroso Ettore al padre, in cambio di un riscatto non disprezzabile; di questo darò anche a te la parte che ti è dovuta».
Così parlò Achille glorioso e tornò alla sua tenda, prese posto sul trono prezioso da cui si era alzato – il trono che si trovava di fronte a quello di Priamo – e si rivolse al re con queste parole:
«Ti è stato reso il figlio, vecchio, come chiedevi, ora giace sopra il letto funebre; al sorgere dell’alba lo vedrai, quando sarà il momento di portarlo via. Ma ora pensiamo a mangiare. Anche Niobe, Niobe dai bei capelli, si ricordò del cibo, lei che perdette dodici figli nella sua casa, sei fanciulle e sei giovani nel fiore degli anni. Adirato con Niobe, Apollo le uccise i figli con il suo arco d’argento, le figlie gliele uccise Artemide, signora dei dardi, perché lei si vantava di essere uguale a Latona, la dea dal bellissimo volto; Latona aveva generato due figli – diceva -, lei invece molti di più; ma fu rono proprio quei due a uccidere tutti i suoi figli. Per nove giorni giacquero a terra i figli di Niobe, immersi nel sangue, non c’era nessuno che potesse dar loro sepoltura perché il figlio di Crono aveva trasformato gli uomini in pietra; gli dei celesti li seppellirono, il decimo giorno. E tuttavia anche Niobe pensò al cibo, dopo essersi saziata di lacrime; e adesso, tra le rocce, nella solitudine dei monti, sul Sipilo dove si narra vi siano le dimore delle ninfe divine che danzano in riva all’Acheloo, qui Niobe, mutata in pietra, cova i dolori che le hanno inflitto gli dei. Anche noi ora, nobile vecchio, anche noi pensiamo a mangiare; potrai piangere tuo figlio più tardi, quando lo avrai riportato a Ilio: allora verserai molte lacrime».
Così disse Achille dai piedi veloci; poi si alzò e uccise un candido ariete; i compagni lo scuoiarono e lo prepararono secondo le regole, lo tagliarono a pezzi, abilmente, infilarono i pezzi sugli spiedi, li arrostirono con ogni cura, poi tolsero tutto dal fuoco; Automedonte prese il pane, lo mise nei bei panieri e lo distribuì sulla tavola; Achille divise la carne; ed essi tesero le mani verso i cibi preparati e imbanditi. Quando furono sazi di cibo e bevande, allora Priamo figlio di Dardano guardava Achille, ammirando la sua bella persona: sembrava un dio, a vederlo. Achille a sua volta guardava il figlio di Dardano, Priamo, e ammirava il suo nobile aspetto, ascoltando le sue parole. A lungo si contemplarono l’uno con l’altro, poi il vecchio re Priamo simile a un dio incominciò a parlare per primo:
«Figlio di Zeus, provvedi perché io abbia un letto al più presto ed entrambi possiamo dormire e godere il sonno soave; sui miei occhi le palpebre non si sono mai abbassate dal giorno in cui mio figlio per mano tua ha perso la vita; senza tregua io piango in preda a infinito dolore rotolandomi nel fango del mio cortile; e oggi soltanto ho assaggiato del cibo e ho inghiottito il vino fulgente; prima non riuscivo a mangiare nulla».
Disse, e subito Achille ordinò ai compagni e alle schiave di preparare un giaciglio nel portico, di mettervi sopra belle coperte di porpora, e stendere dei tappeti e ancora mantelli di lana con cui avvolgersi; uscirono dalla tenda le schiave con le fiaccole in mano e prepararono rapidamente due letti. E Achille dai piedi veloci disse a Priamo:
«Tu dormirai là fuori, vecchio: qualcuno degli Achei che prendono parte al consiglio potrebbe venire qui – vengono sempre a sedersi e a tenere consulto -, e se ti vedessero nella notte rapida e oscura subito andrebbero a dirlo ad Agamennone, signore di eserciti, e il riscatto del morto subirebbe un ritardo… Ma ora parla e dimmi chiaramente, quanti giorni desideri per celebrare i funerali del nobile Ettore? Per tutto questo tempo io non voglio combattere e tratterrò anche l’esercito».
Gli rispose il vecchio re simile a un dio:
«Se mi concedi di celebrare il funerale di Ettore glorioso, se lo farai, Achille, avrai la mia gratitudine. Siamo assediati nella città, tu lo sai, sono lontani i monti da cui dobbiamo prendere legna, e i Troiani hanno molta paura. Per nove giorni lo piangeremo nel palazzo reale, il decimo sarà sepolto e avrà luogo il banchetto funebre, l’undicesimo innalzeremo il tumulo, e il dodicesimo, se è necessario, torneremo a combattere».
A lui disse allora il divino Achille dai piedi veloci:
«Sarà così come vuoi, vecchio re Priamo; sospenderò la battaglia per tutto il tempo che hai chiesto».
Così parlò e posò la sua mano sulla mano destra del vecchio perché non avesse più timore nell’animo. Dormirono dunque là, nel vestibolo, Priamo e il suo araldo, uomini dai saggi pensieri; Achille invece dormiva all’interno della sua tenda ben costruita e accanto a lui si distese Briseide, la bella.
Nella notte tutti dormivano, gli dei e gli eroi che montano i carri, tutti erano in preda al sonno soave; ma non dormiva Hermes, il benefico iddio, e meditava nell’animo come allontanare dalle navi il re Priamo, eludendo la guardia delle sentinelle alle porte. Gli apparve dunque in sogno e gli disse:
«Vecchio, poiché Achille ti ha risparmiato la vita, non pensi al pericolo, non pensi che stai dormendo in mezzo ai nemici; hai riscattato tuo figlio, hai pagato un altissimo prezzo; ma per te, se ti prendessero vivo, tre volte tanto dovrebbero pagare i figli che ti sono rimasti, se lo sapesse Agamennone figlio di Atreo, se tutti gli Achei lo sapessero».
Disse così e il vecchio ebbe paura e fece alzare il suo araldo; Hermes aggiogò per loro i muli e i cavalli, lui stesso li guidò velocemente attraverso il campo, nessuno si accorse di loro. Ma quando furono giunti al guado dello Xanto, il fiume dalle belle acque e dai gorghi profondi, figlio di Zeus immortale, allora al vasto Olimpo Hermes fece ritorno.
L’Aurora dal colore dell’oro si stendeva su tutta la terra ed essi, in lacrime, lanciavano i cavalli verso la città mentre i muli trasportavano il corpo. Nessuno li vide, nessuno dei cittadini e delle donne dalla bella figura, solo Cassandra, simile alla bionda Afrodite, Cassandra che era salita sulla rocca di Pergamo, riconobbe suo padre che stava in piedi sul carro, con accanto l’araldo dalla voce sonora; e vide il corpo di Ettore steso sul letto funebre trasportato dai muli; scoppiò in singhiozzi e poi la sua voce risuonò per tutta la città:
«Venite, uomini e donne di Troia, venite a vedere Ettore, se mai un tempo avete esultato vedendolo tornare, vivo, dalla battaglia, per la gioia della città e di tutto il suo popolo».
Queste parole disse, e nessun uomo, nessuna donna, nessuno rimase in città; colpiti da immenso dolore, si raccolsero tutti presso le porte per incontrare colui che portava il corpo di Ettore. Davanti a tutti la moglie e la nobile madre strappandosi i capelli si gettarono sul carro dalle belle ruote, con le mani accarezzavano la testa del morto. Intorno a loro la folla piangeva.

Priamo
E tutti videro il re rotolarsi nel fango, impazzito dal dolore. Vagava dall’uno all’altro a supplicare che lo lasciassero andare alle navi degli Achei a riprendersi il corpo del figlio. Con la forza, dovettero tenerlo fermo, il vecchio pazzo. Per giorni rimase seduto in mezzo ai figli, chiuso nel suo mantello. Solo pena e lamenti, intorno a lui. Piangevano, uomini e donne, tutti, ripensando agli eroi perduti. Il vecchio aspettò che il fango si indurisse tra i suoi capelli e sulla sua pelle bianca. Poi, una sera, si alzò. Andò nel talamo e fece chiamare la sua sposa, Ecuba. E quando l’ebbe di fronte le disse: “Io devo andare laggiù. Porterò doni preziosi che addolciranno l’animo di Achille. Io devo farlo” . Ecuba prese a disperarsi. “Mio dio, dov’è finita la saggezza per cui andavi famoso? Vuoi andare alle navi, tu, da solo, vuoi finire davanti all’uomo che tanti figli ti ha ucciso? Quello è un uomo spietato, cosa credi, che avrà pietà di te, e rispetto? Stattene qui a piangere nella tua casa, per Ettore noi non possiamo fare più niente, era il suo destino farsi divorare dai cani lontano da noi, preda di quell’uomo a cui strapperei il fegato a morsi.” Ma il vecchio re le rispose: “Io devo andare laggiù. E non sarai tu a fermarmi. Se è destino che io muoia presso le navi degli Achei, ebbene, morirò: ma non prima di aver stretto tra le braccia mio figlio, e pianto tutto il mio dolore su di lui”.
Così disse, e poi fece aprire tutti gli scrigni più preziosi. Scelse dodici pepli bellissimi, dodici mantelli, dodici coperte, dodici teli di lino candido, e dodici tuniche. Pesò dieci talenti d’oro, e prese due tripodi lucenti, quattro lebeti e una coppa meravigliosa, dono dei Traci. Poi corse fuori e a tutta quella gente che piangeva in casa sua si mise a gridare, furibondo “Andatevene via, miserabili, infami, non avete una casa vostra dove andare a piangere?, dovete proprio stare qui a tormentarmi, non vi basta che Zeus mi abbia tolto Ettore, che di tutti i miei figli era il migliore, sì, il migliore, mi avete sentito bene, mi hai sentito, Paride?, e tu, Deifobo, e voi Polite, Agatone, Eleno, lui era il figlio migliore, miserabili, perché non siete morti voi al posto suo? eh? io li avevo figli valorosi, ma tutti li ho perduti, e mi sono rimasti i peggiori, i vanitosi, i bugiardi, quelli buoni solo a danzare e a rubare. Cosa aspettate, infami, uscite da qui e andate a preparare un carro, subito, io devo mettermi in cammino”. Tremavano tutti, davanti alle grida del vecchio re. E dovevate vederli, come corsero via, a preparare un carro e a caricarlo con tutti i doni, e poi i muli e i cavalli, tutto… Nessuno discuteva più. Quando tutto fu pronto arrivò Ecuba. Teneva nella mano destra una coppa piena di dolce vino. Si avvicinò al vecchio re e gliela porse. “Se proprio vuoi andare”, gli disse, “Contro il mio volere, brinda almeno a Zeus, prima, e pregalo di farti tornare vivo.” Il vecchio re prese in mano la coppa e poiché la sua sposa glielo chiedeva la alzò al cielo e pregò Zeus di avere pietà, e di fargli trovare amicizia e compassione là dove sarebbe andato. Poi salì sul suo carro. Tutti i doni li avevano caricati su un secondo carro, guidato da Ideo, l’araldo pieno di saggezza. Se ne partirono, il
re e il fedele servitore, senza scorta, senza guerrieri, soli, nel buio della notte.
Quando arrivarono al fiume si fermarono, per far bere le bestie. E fu lì che videro quell’uomo avvicinarsi, sbucato dal nulla, dal buio. “Scappiamo, mio re”, disse subito Ideo, impaurito. “Scappiamo o quello ci ucciderà.” Ma io non riuscivo a muovermi, ero impietrito dalla paura, vedevo quell’uomo avvicinarsi sempre di più, e non riuscivo a far nulla. Venne verso di me, proprio verso di me, e mi porse la mano. Aveva l’aspetto di un principe, giovane e bello. “Dove stai andando, vecchio padre?”, disse. “Non temi il furore degli Achei, tuoi mortali nemici? Se qualcuno di loro ti vede mentre trasporti tanti tesori, che cosa farai? Non siete più giovani, voi due, come potrete difendervi se qualcuno vi assale? Lasciate che vi difenda io, non voglio farvi del male: tu mi ricordi mio padre.” Sembrava che un dio lo avesse messo sulla nostra strada. Credeva che fossimo scappati da Ilio, che la città fosse in preda al terrore, e noi due ce ne fossimo scappati con tutte le ricchezze che eravamo riusciti a prendere con noi. Sapeva della morte di Ettore, e pensava che i Troiani si fossero dati alla fuga. E quando parlò di Ettore, disse: non era inferiore a nessuno degli Achei, in battaglia. “Ah, giovane principe, ma chi sei tu, che parli così di Ettore?” E lui disse che era un Mirmidone, che era venuto in guerra seguendo Achille e adesso era uno dei suoi scudieri.
Disse che lui Ettore l’aveva visto mille volte combattere, e se lo ricordava quando aveva attaccato le navi. E disse che veniva dall’accampamento degli Achei, dove tutti i guerrieri stavano aspettando l’aurora per attaccare nuovamente Troia. “Ma se vieni da lì, allora l’avrai visto, Ettore, dimmi la verità, è ancora nella tenda di Achille o lo hanno già buttato in pasto ai cani?” “né cani né uccelli l’hanno divorato, vecchio”, rispose. “Puoi non crederci, ma il suo corpo è rimasto intatto. Dodici giorni sono passati dalla sua uccisione, eppure sembra appena morto. Ogni giorno, all’alba, Achille lo trascina senza pietà intorno alla tomba di Patroclo, per oltraggiarlo, e ogni giorno il corpo resta intatto, le ferite si chiudono, il sangue sparisce. Qualche dio veglia su di lui, vecchio: anche se è morto, qualche dio lo ama.” Ah, ascoltavo quelle parole con una gioia nel cuore… Gli offrii quella coppa, la coppa che avevo preso per Achille, gliela offrii e gli chiesi se in cambio riusciva a farci entrare nell’accampamento acheo. “Vecchio, non mettermi alla prova”, disse. “Non posso accettare doni da te all’insaputa di Achille. Chi ruba qualcosa a quell’uomo va incontro a grandi disgrazie. Ma senza compenso, io ti guiderò da lui. E vedrai che, con me, nessuno oserà fermarti.” così disse, e salì sul carro, prendendo le redini e spronando i cavalli. E quando arrivò al fossato, e al muro, nulla gli dissero le sentinelle, passò attraverso le porte aperte, e veloce ci guidò fino alla tenda di Achille.
Era maestosa, sorretta da tronchi di abete e circondata da un grande cortile. La porta, enorme, era di legno. Quell’uomo la aprì, e mi disse di entrare. “Non è bene che Achille mi veda, vecchio. Ma tu non tremare, va’ e inginocchiati davanti a lui. Possa tu commuovere il suo duro cuore.” Allora il vecchio re entrò. Lasciò Ideo a sorvegliare i carri. Ed entrò nella tenda di Achille.
C’erano alcuni uomini che si affaccendavano intorno alla tavola ancora imbandita. Achille era seduto in un angolo, solo. Il vecchio re gli si avvicinò senza che nessuno se ne accorgesse. Avrebbe forse potuto ucciderlo. Ma invece cadde ai suoi piedi, e abbracciò le sue ginocchia. Achille rimase stupefatto, impietrito dalla sorpresa. Priamo gli prese le mani, le mani terribili che tanti figli gli avevano ucciso, e se le portò alle labbra, e le baciò. “Achille, tu mi vedi, sono vecchio ormai. Come tuo padre, ho passato la soglia della triste vecchiaia. Ma lui almeno sarà nella sua terra a sperare di
rivedere un giorno il figlio, di ritorno da Troia. Immensa invece è la mia sventura: cinquanta figli, avevo, per difendere la mia terra, e la guerra me li ha portati via quasi tutti; non mi era rimasto che Ettore, e tu l’hai ucciso, sotto le mura della città di cui era l’ultimo ed eroico difensore. Sono venuto fin qui per riportarmelo a casa, in cambio di splendidi doni. Abbi pietà di me, Achille, nel ricordo di tuo padre: se hai pietà di lui abbi pietà di me che, unico fra tutti i padri, non ho avuto vergogna di baciare la mano che ha ucciso mio figlio.” Gli occhi di Achille si riempirono di lacrime. Con un gesto della mano scostò da sé Priamo, con dolcezza. Piangevano, i due uomini, nel ricordo del padre, del ragazzo amato, del figlio. Le loro lacrime, in quella tenda, nel silenzio. Poi Achille si levò dal suo seggio, prese il vecchio re per mano e lo fece alzare. Guardò i suoi capelli bianchi, la bianca barba, e commosso gli disse: “Tu, infelice, che tante sventure hai patito nell’animo. Dove hai trovato il coraggio per venire fino alle navi degli Achei e inginocchiarti davanti all’uomo che ti ha ucciso tanti figli valorosi? Hai un cuore forte, Priamo. Siediti qui, sul mio seggio. Dimentichiamo insieme l’angoscia, che tanto piangere non serve. E destino degli uomini vivere nel dolore, e solo gli dei vivono felici. E la sorte, imperscrutabile, che dispensa bene e male. Mio padre, Peleo, era un uomo fortunato, primo fra tutti gli uomini, re nella sua terra, sposo di una donna che era una dea: eppure la sorte gli diede un solo figlio, nato per regnare, e adesso quel figlio, lontano da lui, corre veloce verso il suo destino di morte, seminando la rovina tra i suoi nemici. E tu, che eri così felice un tempo, re di una grande terra, padre di molti figli, padrone di una fortuna immensa, adesso sei costretto ogni giorno a svegliarti in mezzo alla guerra e alla morte. Sii forte, vecchio, e non tormentarti: piangere tuo figlio non lo riporterà in vita”. E con un gesto invitò il vecchio re a sedersi, sul suo seggio. Ma quello non volle, disse che voleva vedere il corpo del figlio, coi suoi occhi, solo quello voleva, non voleva sedersi, voleva suo figlio. Achille lo guardò irritato. “Adesso non farmi arrabbiare, vecchio. Ti ridarò tuo figlio, perché se sei arrivato vivo fin qui, vuol dire che è stato un dio a guidarti, e io non voglio dispiacere agli dei. Ma non farmi arrabbiare, perché sono anche capace di disubbidire agli dei.” Il vecchio re tremò di paura, allora, e si sedette, come gli era stato ordinato. Achille se ne uscì dalla tenda, coi suoi uomini. Andò a prendersi i preziosi doni che Priamo aveva scelto per lui. E due teli di lino, e una tunica, lasciò sul carro, perché vi avvolgessero il corpo di Ettore quando sarebbe stato pronto per essere riportato a casa. Poi chiamò le schiave e ordinò loro di lavare e ungere il cadavere dell’eroe, e di fare tutto questo in disparte, perché gli occhi di Priamo non vedessero, e non dovessero soffrire. E quando il corpo fu pronto, Achille stesso lo prese tra le braccia, lo sollevò e lo depose sul letto funebre. Poi tornò nella tenda e si sedette di fronte a Priamo. “Ti è stato reso il figlio, vecchio, come tu volevi. All’alba lo vedrai, e te lo potrai portare via. E adesso ti ordino di mangiare con me.” Prepararono una sorta di banchetto funebre, e quando il pasto fu finito, rimanemmo là, uno di fronte all’altro a parlare, nella notte. Non riuscivo a non ammirare la sua bellezza, sembrava un dio. E lui mi stava ad ascoltare, in silenzio, rapito dalle mie parole. Per quanto possa sembrare incredibile, passammo quel tempo ad ammirarci. Tanto che alla fine, dimenticando dov’ero, e perché ero lì, io chiesi un letto, perché erano giorni che non dormivo, trafitto dal dolore: e me lo prepararono, con tappeti preziosi e coperte di porpora, in un angolo, perché nessuno degli altri Achei mi vedesse. Quando tutto fu pronto, Achille venne da me e mi disse: “Fermeremo la guerra per darti il tempo di onorare tuo figlio, vecchio re”. E poi mi prese la mano, e la strinse, e io non ebbi più paura.
Mi svegliai nel cuore della notte, che tutti dormivano, intorno a me. Dovevo essere impazzito perpensare di aspettare l’alba là. Mi alzai, in silenzio, andai ai carri, svegliai Ideo, attaccammo i cavalli e, senza che nessuno ci vedesse, partimmo. Attraversammo nel buio la pianura. E quando l’Aurora dal colore d’oro scivolò su tutta la terra, arrivammo alle mura di Troia. Dalla città ci videro le donne e si misero a gridare che il re Priamo era tornato, e con lui il figlio Ettore, e tutti si riversarono fuori dalle porte, correndoci incontro. Tutti volevano accarezzare la bella testa del morto, piangendo e alzando sordi lamenti. A fatica il vecchio re riuscì a spingere i carri fin dentro le mura, e poi nella reggia. Presero Ettore e lo posero su un letto intarsiato. Intorno a lui si alzò il lamento funebre. E le donne, una ad una, gli andarono accanto, e tenendo la sua testa tra le mani gli dissero addio.
A. BARICCO, Iliade, Feltrinelli, 2004