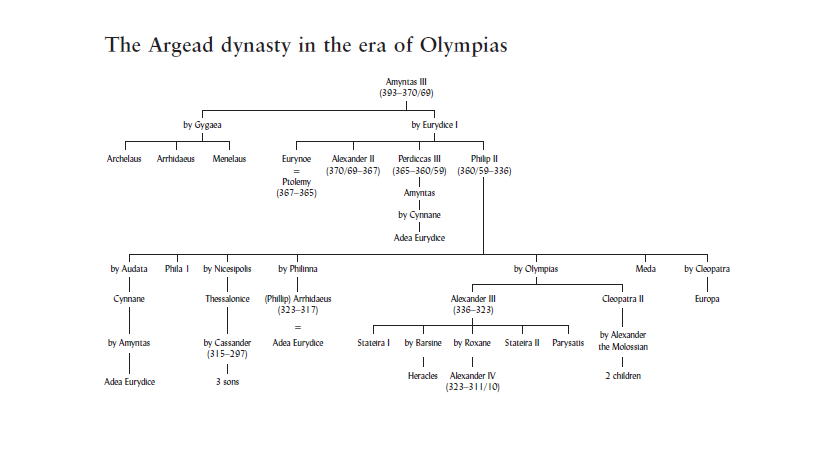Il III secolo d.C. fu definito l’«età dell’angoscia», ora ci frastorna lo scontro di civiltà Ma è il solito urto tra privilegiati e diseredati, che talvolta emerge con furore mistico
Luciano Canfora
“Corriere della Sera – La Lettura”, 25 gennaio 2015
All’inizio del XXI secolo è nato, contro ogni aspettativa, un «Califfato» che profetizza la fine dell’Occidente, così come nell’ultimo ventennio del secolo XX il khomeinismo profetò la fine dell’Urss. Nel momento più acuto della lunga crisi dell’impero romano (III secolo d.C.) sorse una unità statale possente, che staccò pezzi significativi dalla compagine dell’impero: Siria, Egitto, Asia Minore. Fu il regno di Zenobia di Palmira, che costrinse l’imperatore Aureliano (270-275 d.C.) a una dura guerra per riconquistare l’Oriente e in particolare l’Egitto, al prezzo — tra l’altro — della distruzione di un intero quartiere di Alessandria e della sua mitica biblioteca.
Difficile indicare un più drammatico simbolo di «decadenza». Quasi un secolo dopo, uno storico siriaco che scriveva in latino ed era rimasto pagano, Ammiano Marcellino, rievocava la terribile e distruttiva vicenda di Alessandria nel XXII libro delle sue Storie . Oggi alcuni pensano che il mondo stia vivendo un nuovo «terzo secolo»: sta davvero finendo una civiltà?
Ogni epoca ha udito paventare o profetare la decadenza. Questo potrebbe portare a concludere che la decadenza non esiste e che, semmai, è la proiezione dell’allarme di alcuni o di molti, o anche dell’«angoscia» di una parte, più sensibile e più pensante.
L’allarme cresce al cospetto di grandi rivolgimenti. Nell’età delle guerre civili romane, Lucrezio ravvisa un indizio di decadenza persino nella realtà fisica: un tempo la terra produceva corpi più grandi, giganteschi. Molti anni fa, Santo Mazzarino, in un piccolo libro geniale, La fine del mondo antico (1959), apriva l’ultimo capitolo con i versi di Verlaine: «Io sono l’impero alla fine della decadenza, che guarda il passaggio dei grandi barbari bianchi, componendo acrostici indolenti» (1883). Qui torna il motivo della grandezza dei corpi. I popoli nuovi sono anche fisicamente «più grandi», e l’impero in decadenza li osserva indolente. Aggiungiamo che ciò che appare «decadenza» ad alcuni protagonisti o testimoni non è affatto tale per altri. Quelle che, nella prospettiva dell’assetto imperiale romano, e nella percezione dei suoi ceti dirigenti, nonché di una parte della storiografia moderna, erano le «invasioni barbariche», nella storiografia germanica sono le «migrazioni di popoli»: fenomeno dunque positivo che sta alla base della compenetrazione latino-germanica da cui nasce il mondo moderno.
Crisi acute — all’apparenza irreversibili — scandirono la storia della compagine romana ben prima del «fatale» III secolo. Orazio, testimone diretto del riaprirsi delle guerre civili dopo la morte di Cesare, prevede, nell’ Epodo XVI , che i barbari verranno ad abbeverare i loro cavalli in Campidoglio. Analoga fu la percezione, tra i contemporanei, dell’anno 69 d.C., tra la morte di Nerone e l’avvento di Vespasiano: riesplose allora la guerra civile e parve profilarsi il fallimento non solo della dinastia giulio-claudia, ma della costruzione augustea come tale. E così dalla crisi esplosa alla morte di Commodo (180-192), emerse, nel sangue, la dinastia severiana; e, all’estinguersi di questa, un «semibarbaro», Massimino il Trace (235-238), salì sul trono dei Cesari.
Non sarà inutile ricordare che proprio la vicenda del breve e devastante governo di Massimino, drammatizzata da Erodiano nella Storia dopo Marco , fu — insieme all’esperienza della rivoluzione russa — tra gli spunti che misero in moto la fantasia storiografica di uno dei grandi del Novecento: Mikhail Rostovtsev. Per lui — ormai esule — nell’opera sua più celebre, la Storia economica e sociale dell’impero romano (1926), la rivoluzione russa del 1917 aveva rappresentato l’analogo della sommersione della elevata civilitas ellenistico-romana da parte della semibarbara massa contadina.
La scansione per secoli, si sa, è sempre approssimativa. Nondimeno è lecito dire che la percezione del tramonto di un mondo e l’aspettativa di una nuova, salvifica, linfa spirituale furono sentimenti diffusi nel tempo che va dal sempre più stanco governo di Marco Aurelio (161-180 d.C.) alla rifondazione dello Stato ad opera di Diocleziano (284-305 d.C.). Perciò quel secolo fu definito da un grande storico irlandese, Eric Dodds (1893-1979), «età dell’angoscia», in un famoso ciclo di conferenze poi divenute libro (1964).
Ernest Renan si era spinto oltre e aveva parlato di fine del mondo antico già con Marco Aurelio. Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia di Dodds cercava di cogliere i patemi e le aspettative che accomunavano le varie correnti spirituali dell’epoca al di là della distinzione, non di rado arbitraria, tra «pagani» e «cristiani».
L’iniziativa di Eugenio La Rocca di dar vita, a Roma, ai Musei Capitolini, a una grande mostra, ricca di oltre 200 pezzi, dedicata appunto al «secolo dell’angoscia», non soltanto offre materiali di primaria importanza, illustrativi di quell’epoca, ma, com’è giusto, rimette in discussione la definizione stessa, così fortunata, di Dodds. La Rocca mette alla prova la tenuta storiografica di tale concetto nell’ambito storico-artistico. Dalla sua analisi risulta chiaro quanto sia deludente il meccanicismo di chi ha posto in relazione la «crisi del III secolo» con le nuove forme di espressione artistica, in particolare la ritrattistica e il gigantismo dei sarcofagi. Una impostazione così sanamente storicistica si coglieva già nel libro «giovanile» di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Storicità dell’arte classica (1943) di cui parlò Giorgio Pasquali, con schietto entusiasmo, nel «Corriere della Sera» del 24 giugno di quell’anno: «Per Bandinelli — scrisse Pasquali — l’ellenismo figurativo dura a Roma da Silla a Traiano; sotto Traiano comincia un’arte nuova, romana, che giunge sino a Teodosio». È dunque già nel II secolo, e sempre più dalla metà in avanti, che si produce una trasformazione profonda, che investe i più diversi ambiti: artistico, religioso, filosofico, politico. E prosegue ben oltre Diocleziano.
Lo stesso Dodds, in un precedente lavoro divenuto ben presto celeberrimo, I Greci e l’irrazionale (1950), aveva infranto l’incantesimo «apollineo»: aveva fatto emergere dalle nostre fonti, spesso, in precedenza, lette selettivamente o non capite, il magma cultural-religioso che, nel mondo greco, costituiva una sorta di realtà alternativa rispetto a quella razionale e luminosa su cui fa perno la lettura classicistica. Quel magma ebbe sue forme, si nutrì di culti misterici e di culti stranieri (Tracia e Frigia ne furono le due aree matrici) i quali guadagnarono terreno nei ceti cosiddetti «bassi», ma attrassero anche quelli «alti».
Di questa genealogia intellettuale, un ramo fu Il tramonto dell’Occidente di Spengler (1918), ma è giusto ricordare che l’intuizione di partenza era racchiusa nel memorabile ancorché indigesto saggio di Nietzsche sull’ Origine della tragedia, là dove l’allora filologo fissava, con un colpo d’ala, le due categorie sempre confliggenti del «dionisiaco» e dell’«apollineo». In momenti di grave crisi, quel magma fuoriesce come lava.
La prospettiva più aderente alla realtà è dunque quella che considera forze e pulsioni siffatte come stabilmente e «pericolosamente» latenti. L’«angoscia» non è appannaggio di un determinato secolo. Il nostro presente viene frastornato dalla dottrina del «conflitto di civiltà», e la cronaca apparentemente ne ribadisce la fondatezza. Ma, a ben vedere, si tratta dell’eterno conflitto tra l’alto e il basso, tra privilegiati e diseredati, che attraversa epoche e continenti; e che, quando i programmi etico-politici più razionali vengono sconfitti, si esprime come furore mistico-religioso-palingenetico.

L’Impero Romano e il suo lato oscuro
Ai Musei Capitolini dal 28 gennaio la rassegna dedicata al III secolo dopo Cristo, tempo di ansie religiose e presagi di decadenza
Maurizio Bettini
“ La Repubblica”, 22 gennaio 2015
SI ERA nel 1970 e La Nuova Italia mandò in libreria Pagani e Cristiani in un’epoca d’angoscia, un libro di Eric R. Dodds. L’autore, regius professor di Greco a Oxford, era in realtà già noto in Italia per un altro libro dal titolo ugualmente suggestivo: I Greci e l’irrazionale , apparso una decina di anni prima. Che cosa introduceva Dodds, con questa nuova opera, nella nostra visione dell’età imperiale romana e del mondo antico in generale?
Sostanzialmente due cose: il richiamo a un poema composto nel 1947 da Wystan Hugh Auden, The Age of Anxiety e soprattutto l’idea che una determinata epoca della storia umana potesse aver condiviso uno stesso stato d’animo, una medesima condizione spirituale: per non dire un medesimo inconscio. Sappiamo che nel periodo compreso fra Marco Aurelio e Costantino l’impero romano fu caratterizzato da una crescente spirale di mali: decadenza sociale, crisi economica, pressione ai confini dell’impero da parte di altre popolazioni, conflitti intestini, strapotere dell’esercito, e così di seguito. Nell’interpretazione di Dodds, a questa realtà profondamente negativa avrebbe fatto riscontro, in campo spirituale, la crescita di un nuovo sentimento religioso, più profondo, più individuale, tale da aprire la strada all’affermazione di culti centrati sull’immortalità e la sopravvivenza dell’anima: fra cui il cristianesimo, ovviamente, che in breve avrebbe assunto una posizione dominante. Questa trasformazione religiosa dell’impero si sarebbe dunque consumata sullo sfondo di uno stato d’animo ben individuato e largamente condiviso: l’angoscia. Per la verità l’edizione originale del libro di Dodds aveva per titolo Pagans and Christians in an Age of Anxiety . E come rileva Eugenio La Rocca nel bel saggio che inaugura il catalogo di questa mostra, è difficile capire perché il termine anxiety – “ansietà”, “inquietudine” – fosse stato tradotto con una parola tanto più marcata come “angoscia”. In ogni caso fu forse anche per questa scelta editoriale, un po’ spiccia ma efficace, che il libro suscitò molta attenzione. Questa formula foriera di inquietudine, “età dell’angoscia”, torna adesso nel titolo della mostra che si apre il 28 gennaio ai Musei Capitolini (fino al 4 ottobre), dedicata al periodo che Dodds mise al centro delle sue ricerche. Inutile dire che un momento come quello odierno, in cui certezze sociali, economiche e culturali sembrano scomparire, pare fatto apposta per resuscitare i fantasmi che, secondo Dodds, agitarono pagani e cristiani. Per altro verso, però, non dobbiamo neppure semplificare troppo il senso delle trasformazioni che ebbero luogo nel III secolo d. C. Sarebbe sbagliato affermare che l’afflusso di religioni “straniere” a Roma in quel periodo costituì un fenomeno radicalmente nuovo: il politeismo antico ha sempre praticato, e accettato, la trasmigrazione degli dèi, cercare e accogliere nuovi culti faceva parte del sistema. Così come è difficile accettare l’idea che l’avvento di nuove religioni, e soprattutto quello del Cristianesimo, fosse dovuto esclusivamente al bisogno di spiritualità che travagliava gli abitanti dell’impero: con l’implicita presupposizione che i culti tradizionali fossero inadeguati a soddisfare questo bisogno e come tali già predestinati a soccombere. Si tratterebbe infatti di un’interpretazione più teologica che non storica. Ma non è tanto questo che deve interessarci, quanto l’angoscia, o l’ansia, collocate da Dodds sullo sfondo della sua ricostruzione. In altre parole, com’era arrivato l’autore a trasformare una condizione psicologica in una categoria buona per interpretare la storia?
Per comprenderlo conviene rifarsi all’altro libro di Dodds: I Greci e l’irrazionale. Siamo nel 1948, la seconda guerra mondiale è appena terminata, la prima non è affatto lontana. La storia recente dell’Europa mostra, in altre parole, che la cultura europea, apparentemente così razionale, in realtà non lo era affatto. Probabilmente fu questo il motivo che spinse Dodds a dedicare le sue energie alla parte più “scandalosa” della Grecia: la pazzia vista come fenomeno positivo, veicolo di ispirazione poetica o di contatto con la divinità; il sogno, alla cui realtà significativa i Greci sembrano in qualche modo credere; lo sciamanesimo, che Dodds vede all’origine di una nuova dottrina dell’anima, concepita adesso come soggetto autonomo rispetto all’essere umano nel suo complesso. Nelle sue ricerche l’obiettivo di Dodds è quello di sostituire l’immagine dei Greci come popolo dominato dalla ragione – amministratori unici del lógos – con una in cui trova piena cittadinanza anche ciò che al lógos si oppone. Ecco perché, oltre all’antropologia, ne I Greci e l’irrazionale l’orizzonte metodologico include anche la psicoanalisi, nella convinzione che l’inconscio possa esercitare un grosso peso nelle vicende umane: e quindi anche nei fenomeni storici o culturali. A Dodds insomma sta a cuore mettere in luce il lato oscuro, profondo di una cultura o di un popolo, ciò che si agita nella sua psiche: sia che si tratti dei Greci, sia che si tratti degli abitanti dell’impero romano divenuti preda dell’ansia.
La vita intellettuale di una persona, comunque, è una cosa complicata, e quella di Eric R. Dodds sembra esserlo stato anche più di altre. Il fatto è che egli fu personalmente e individualmente un attento osservatore di fenomeni psicologici, specie se oscuri e irrazionali. Il regius professor, infatti, per anni partecipò alle sedute della Society for Psychical Research, di cui divenne anche presidente: una società che si occupava di manifestazioni extrasensoriali, di trasmissione del pensiero e di fenomeni medianici. Un classicista oggi di fama internazionale, il quale fu studente ad Oxford quando Dodds era ormai in pensione, mi ha raccontato una volta questo aneddoto. Dopo aver preso il suo PhD discutendo una tesi sulla religione greca, il giovane studioso aveva inviato a Dodds il libro che aveva tratto dal proprio lavoro. Questo dono gli era valso un invito per il tè a casa dell’illustre maestro. Ci era andato, piuttosto emozionato, aveva suonato il campanello e Dodds era venuto ad aprirgli la porta. «Grazie per il suo libro, giovanotto» gli aveva detto ancora sulla soglia «ma debbo avvertirla che non mi occupo più di religione greca. Mi interessa solo lo spiritismo».

Da Commodo a Diocleziano l’addio all’antico
Il passaggio da un sovrano all’altro segna anche in campo artistico l’abbandono dei canoni classici
Giuseppe M Della Fina
“ La Repubblica”, 22 gennaio 2015
AL centro della mostra L’età dell’angoscia. Da Commodo a Diocleziano ( a cura di Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce e Annalisa Lo Monaco) è un periodo di particolare importanza per la storia di Roma: il III secolo d. C. che si aprì con uno sguardo rivolto all’indietro, verso l’azione di grandi imperatori quali Traiano, Adriano e Marco Aurelio e si chiuse guardando in avanti in direzione di un mondo completamente diverso da quello conosciuto sino ad allora. Cento anni che sembrano essere durati molto di più: una consapevolezza non estranea agli stessi contemporanei vissuti tra assetti istituzionali di lunga tradizione che crollavano e altri che tentavano di sorgere, tra una religione millenaria che non dava più risposte e altre – tra le quali il cristianesimo destinato ad affermarsi – che si accingevano a sostituirla. Lungo il percorso espositivo, il racconto, che va dalla morte per avvelenamento di Commodo (192 d. C.) alla fine del regno di Diocleziano (305 d. C.), è affidato a opere d’arte e a prodotti dell’artigianato artistico del tempo. Una produzione sulla quale aveva riflettuto a lungo lo storico dell’arte antica Ranuccio Bianchi Bandinelli che, nel suo bagaglio culturale, aveva una capacità di lettura formale sostanzialmente andata perduta. In uno dei suoi libri più fortunati Roma. La fine dell’arte antica ha osservato: «la caratteristica fondamentale è l’abbandono dei canoni classici e l’accentuazione del modellato in senso coloristico con il fine di raggiungere, in ogni caso, una espressione marcata. Se l’angoscia corrispondeva a un sentimento diffuso, vi è anche, in questo secolo, una manifestazione di volontà di potenza che non rifuggirà da nessun mezzo per affermarsi».
Volontà di potenza, angoscia che potremo andare a ritrovare nella selezione delle opere esposte. Alla nostra ricerca aggiungerei il desiderio di riuscire a riconoscere, nel nuovo, il bagaglio culturale ellenistico che strattonato, incompreso, negato riesce comunque ad affiorare nella posizione di un corpo, nell’atteggiamento di una testa, nella resa dei capelli, o in altri particolari ancora minori. La volontà di comprendere la forza di una tradizione riproposta talvolta contro le indicazioni degli stessi committenti e affidata ai cartoni logori di una bottega artigiana, all’insegnamento di un maestro, all’abilità di mani allenate, ai condizionamenti dettati dagli attrezzi stessi del mestiere. In alcuni casi il gioco si rivela semplice, quasi scoperto con uomini e donne raffigurati quali personaggi della religione e della mitologia pagana, come – modello ricorrente – Ercole: si osservi il busto in marmo dell’imperatore Commodo rinvenuto negli Horti Lamiani a Roma. O i riferimenti frequenti alla figura di Alessandro Magno. In altri esempi può rivelarsi più sottile e controverso. Ci si può soffermare allora di fronte a un pannello in opus sectile con la testa del dio Sol, scelto non a caso per la copertina del volume di Bianchi Bandinelli. Giunge da un mitreo sottostante la chiesa di Santa Prisca a Roma che, a sua volta, si era insediato su un edificio precedente a destinazione residenziale. Vi è stato chi ha voluto identificarlo con la domus dell’imperatore Traiano e, in tal caso, la suggestione sarebbe fortissima. La divinità è raffigurata, utilizzando tarsie di calcare e di marmi dal colore differente, in una posa scomposta, nell’atto di voltarsi verso sinistra, con le ciocche dei capelli disordinati. Il volto presenta grandi occhi rivolti verso l’alto, le sopracciglia ondulate, la fronte corrugata, la bocca dischiusa: riesce a trasmettere la drammatica tensione del tempo in cui venne realizzato, probabilmente tra il 235-250 d. C. Ma in esso si può intravedere l’archetipo scultoreo dell’Alessandro Magno di Lisippo, facendoci intuire la complessità ambigua dei decenni che cambiarono definitivamente Roma e il suo impero.

Sol Invictus
Cinzia Dal Maso, Il bello dell’angoscia. Ai Musei Capitolini uno spaccato sull’arte spettacolare prodotta durante la terribile crisi che investì Urbe nel III secolo d. C., “Il Sole 24 ore”, 15 febbraio 2015
Cinquanta imperatori in cent’anni, morti quasi tutti per mano assassina: che altro dire per illustrare il Terzo secolo d.C., l’epoca più concitata della storia dell’Impero romano? L’età della crisi. Crisi politica: scomparvero le dinastie imperiali e gli imperatori furono poco più che fantocci in mano agli eserciti. Crisi istituzionale: le numerose riforme corrosero a poco a poco le fondamenta del governo e dell’esercito di Roma. Crisi economica, tra svalutazioni monetarie, guerre esterne e civili, e l’Impero che non garantiva più sicurezza. Crisi sociale, tra comunità disgregate, carestie, epidemie, e disperati migranti in cerca di fortuna.
Fu «L’età dell’angoscia», come recita il titolo della mostra in corso ai Museo Capitolini a Roma, richiamandosi alla famosa opera di Eric Dodds. Un titolo poco invitante, in questi nostri tempi che ricordano per molti aspetti le crisi antiche. E non del tutto calzante, come la mostra spiega molto bene: i curatori Eugenio La Rocca, Annalisa Lo Monaco e Claudio Parisi Presicce aggiungono che fu anche, e soprattutto, l’età dell’ambizione.
Durante le crisi la ricchezza non svanisce ma si distribuisce diversamente, concentrandosi in poche mani. Il Terzo fu il secolo delle grandi ricchezze private e delle proprietà fondiarie che s’ingrandivano a dismisura. Il secolo della decadenza dell’edilizia pubblica a vantaggio del lusso privato: ci sono in mostra argenterie sontuose, oltre agli eleganti affreschi da una dimora da via Nazionale a Roma da troppo tempo chiusi nell’Antiquarium comunale. E i modellini dal Museo della civiltà romana (tuttora chiuso) mostrano una Roma che cercò sempre più di catturare la popolazione con spettacoli e le terme più grandi e belle dell’antichità. Ma anche una città che si riempì di caserme per mantenere un ordine pubblico difficile, e che Aureliano cinse di potenti mura per proteggerla come mai prima. Una città sempre meno “capitale”, in un’Italia sempre meno centrale rispetto all’Impero. Dopo l’editto di Caracalla del 212 d.C. tutti i cittadini dell’Impero godettero degli stessi diritti, e con Diocleziano alla fine del secolo l’Italia non fu che una delle sue molte province. Fu anche il secolo del boom dei cosiddetti “culti orientali”, primo fra tutti il Cristianesimo che subì le persecuzioni più dure. E poi Mitra, Sabazio, Giove Dolicheno, Iside, Cibele: tutti culti molto antichi – si osserva in una ricca sezione della mostra – che nel III secolo hanno sicuramente fornito risposte alle inquietudini e ai pressanti bisogni di salvezza personale. Forse, però, la loro ampia diffusione in occidente è dovuta anche ai molti “migranti” che da un capo all’altro dell’Impero portavano con sé il proprio credo. Chi meglio di noi, oggi, può comprendere ciò?
L’ambizione del secolo, tuttavia, si vede soprattutto nei ritratti: sempre più gente comune amò farsi ritrarre in vesti divine o eroiche, come Ercole, Onfale o Venere. E gli imperatori – personaggi disposti a tutto per acquisire un potere che sapevano essere comunque precario – si astraevano sempre più dagli umani a rappresentare col proprio ritratto quel potere assoluto che di fatto non avevano. I loro tratti diventavano sempre meno realistici e più schematizzati, con gli occhi sporgenti e rivolti verso l’alto a significare il loro essere come un dio, simbolo della Roma eterna.
La mostra si apre con una galleria di ritratti, come oramai consuetudine nella serie di mostre «I giorni di Roma» di cui questo è il quarto appuntamento.
Se altre volte, però, la selva di volti rischiava di parlare poco al visitatore, in questo caso cattura a prima vista.
In un allestimento realmente spettacolare, scorrono i “grandi” del secolo in ordine cronologico, e si è spinti a scoprirne le gesta, a capire quale esercito li ha acclamati e quale ne ha decretato la fine. E nonostante le schematizzazioni e gli occhi tutti uguali, paiono avere più carattere dei loro più duraturi predecessori: allora si viveva d’immagine molto più che di sostanza.
Tra tanti volti “sognanti”, spicca sicuramente l’enorme statua bronzea di Triboniano Gallo dal Metropolitan, ma lo sguardo si posa curioso soprattutto sui raffinati filosofi in trono – il giovane, l’uomo maturo e l’anziano – dalla villa di Dioniso a Dion in Macedonia.
Oppure su alcuni volti di gente comune, benestanti che si facevano ritrarre come filosofi: mostrano, palpabile, tutto il «dolore di vivere» del secolo.

Una grande, bella mostra ripercorre «L’età dell’angoscia» nell’Impero Romano del III Secolo. Una stagione difficile, così lontana eppure così vicina alla nostra contemporaneità
Angoscia: in campo psicologico il termine designa uno stato doloroso di ansietà. Nella tradizione filosofica, la parola assunse un significato definito con Soren Kierkegaard che descrisse lo stato di smarrimento che l’uomo prova quando è posto di fronte all’incertezza e all’ndeterminatezza della sua esistenza. A differenza della paura, indispensabile meccanismo di difesa che scatta in presenza di un determinato pericolo, l’angoscia non si riferisce a nulla di preciso e di determinato ma, secondo il filosofo danese, designa quello stato emotivo dell’esistenza umana che non è una realtà, ma una possibilità, nel senso che l’uomo diventa ciò che è in base alle scelte che compie e alle possibilità che realizza. W.H. Auden, poeta anglo-americano dalla vita travagliata, che si appassionò alle teorie kirkegaardiane, nel ‘47 aveva pubblicato The Age of Anxiety, poema capace di mettere in luce il vuoto dell’esistenza nel periodo della seconda mondiale, caratterizzato dalla conversione o ritorno al Cristianesimo e dalla volontà di aderire a un credo religioso, da un «salto nella fede». Più recentemente, nel 1965, Eric Dodds, che di Auden era stato amico, aveva tracciato un importante affresco della crisi che attanagliò l’Impero romano nel terzo secolo dopo Cristo dal titolo Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia.
È stata quella angoscia, che da Kirkegaard arriva fino a Dodds, a fornire l’ispirazione per il titolo di una bellissima mostra a cura di Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce e Annalisa Lo Monaco L’Età dell’Angoscia. Da Commodo a Diocleziano (180-305 d.C.), che si è aperta in questi giorni ai Musei Capitolini di Roma e vi rimarrà all’ottobre 2015, importante appuntamento del ciclo “I Giorni di Roma”, progetto quinquennale che alterna esposizioni a carattere prettamente monografico (Ritratti. Le tante facce del potere, Costruire un Impero), a mostre dal taglio diacronico (L’Età della Conquista, L’Età dell’Equilibrio, L’Età dell’Angoscia), dall’epoca repubblicana fino all’epoca tardo-antica.
Ciò che colpisce il visitatore di questa mostra è la sua incredibile attualità. La mostra – spiegano gli organizzatori – racconta la diffusa crisi spirituale e religiosa che in un clima di ansia generalizzata portò a un abbandono delle religioni tradizionali e all’adesione sempre più massiccia al culto di divinità provenienti dall’Oriente: Iside, Cibele, Mithra, Sabazio. Oltre a loro, naturalmente, Cristo. L’ansia derivava da alcuni problemi concreti e materiali: guerre civili, crisi finanziarie ed economiche, carestie, epidemie (come quelle nel corso dei principati di Marco Aurelio e Gallieno) e la perenne pressione dei barbari ai confini. Ad astrologi, indovini e oracoli gli uomini e le donne del tempo ripetevano frequentemente le stesse domande: «mi ridurrò a mendicare?», «avrò il mio salario?», «sarò venduto schiavo?».
In breve la speranza di un futuro più sicuro era talmente diffusa e pressante da alimentare in chiunque quella che gli storici dell’antichità chiamano un’aspettativa di salvezza, legata in primo luogo alla figura dell’imperatore, in teoria garante della giustizia, della sicurezza militare dell’Impero e anche suprema autorità religiosa. Il collasso dei sistemi di riferimento sociali ed economici hanno sempre avuto come effetto principale quello di compromettere la quotidianità della vita delle persone, che in modo progressivo e rapido, si trovano ad affrontare l’angoscia del reale.
Difficile non fare parallelismi che richiamano alle condizioni del presente e alle sue incertezze. Agli alti tassi di disoccupazione che affliggono il mondo del lavoro, al malessere delle giovani generazioni che, con o senza diploma, con o senza laurea non riescono a inserirsi nel mondo produttivo, alle migliaia di piccole aziende costrette a chiudere i battenti impossibilitate a reggere il passo con i costi crescenti e un mercato in costrizione, a quella «società stremata da sei anni di crisi e che ormai si aspetta solo il peggio», come certifica l’ultima analisi del Censis, i cui le famiglie si barricano dietro un risparmio che cresce nonostante il crollo dei redditi, ma che non si traduce né in consumi né in investimenti, un vero e proprio «cash di tutela». Un problema certamente non solo italiano. È di questi giorni la pubblicazione di uno studio raggelante della prestigiosa rivista scientifica americana Lancet che riguarda i suicidi dovuti alla perdita del lavoro. La ricerca è stata effettuata in collaborazione con il sociologo svizzero Carl Nordt, del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Zurigo, e parla di 45 mila morti all’anno, un quinto del totale di quanti si sono tolti la vita, in 63 Paesi, tra il 2000 e il 2011. Magra consolazione per il nostro paese è che da noi la percentuale di 1,7 casi per 100.000 si è mantenuta bassa rispetto ad altri Paesi, alla Lituania per esempio dove è dieci volte più alta.
Il valore di questa mostra che ha coinvolto prestigiosi musei internazionali come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Landesmuseum e il Zentralmuseum di Magonza, il Landesmuseum di Treviri,la Glypthoteke il Museo dell’Università di Monaco di Baviera, il Louvre di Parigi e il Museo Archeologico Nazionale, il Museo dell’Acropoli di Atene, il Museo Archeologico di Dion e il Museo Archeologico di Astros e importanti collezioni private, al di la del suo indubitabile aspetto di testimonianza artistica della stagione storica analizzata, sta soprattutto nella sua funzione di riflessione sugli effetti del collasso dei sistemi di riferimento sociali ed economici, che hanno finito per compromettere la quotidianità della vita delle persone, che in modo progressivo e rapido, si trovano ad affrontare l’angoscia del reale. Nella recente storia mondiale due eventi hanno avuto per la prima volta la capacità di modificare e accomunare gli esseri umani su scala globale: il primo conflitto mondiale e il crollo di Wall Street del ’29 anche detta «la grande depressione». In entrambi i casi, per la prima volta l’uomo è stato testimone di fenomeni i cui effetti non erano più esclusivamente legati ai propri confini Nazionali, ma avevano la capacità di compromettere e modificare geografie economiche e sociali su scala mondiale. La percezione che gli sconvolgimenti economici, finanziari e sociali avessero risonanze globali amplificò incredibilmente l’angoscia, compromettendo e modificando il sentire collettivo. Non ultime, le crisi dei bond Argentini del 2001/2002 e dei mutui subprime negli Stati Uniti nel 2006, propagatesi poi in tutto il mondo dell’economia e della finanza, hanno determinato fenomeni imprevedibili in cui piazze, strade e palazzi dello Stato divengono luoghi in cui i popoli si barricano per esorcizzare, arginare e combattere l’angoscia del fallimento di sistemi culturali inadeguati. La presenza della parola crisi diventa permanente.
La mostra L’età dell’Angoscia approfondisce dunque la conoscenza dei grandi cambiamenti che segnarono l’età compresa tra i regni di Commodo (180 – 192 d.C.) e Diocleziano (284 – 305 d.C.): fase definita già dagli storici del tempo come «il passaggio dall’Impero d’oro (quello di Marco Aurelio) a uno di ferro arrugginito». In poco meno di centocinquanta anni infatti l’Impero cambiò la propria fisionomia, arrivando all’instaurazione della Tetrarchia e alla perdita del ruolo di capitale della città di Roma. In questo lasso di tempo le cronache evidenziano alcuni elementi che ancora una volta richiamano, seppur con le dovute differenze, la nostra attualità, quali: l’aumento delle pressione di popoli sui confini dell’impero, le spinte secessioniste (si pensi all’Impero delle Gallie e al Regno di Palmira), i disordini interni (che comportarono riforme strutturali della tradizionale unità militare romana, la legione), la crisi del tradizionale sistema economico, l’inflazione e la conseguente necessità di aggiornare continuamente la moneta, e soprattutto, la grave instabilità politica. Determinante fu la fine della trasmissione del potere su base esclusivamente dinastica e il conseguente potere che andò a concentrarsi nelle mani dell’esercito, capace di imporre gli imperatori e di eliminarli. È un mondo che muta definitivamente la propria struttura sociale, con lo sfaldamento delle istituzioni e il parallelo emergere di nuove forze sociali. Le graduali tappe di queste trasformazioni si riflettono sui modelli figurativi e del linguaggio formale della scultura, che si carica di un nuovo e forte accento patetico.
Duecento opere, imponenti statue in marmo e bronzo, a grandezza naturale, in alcuni casi di misura colossale, busti e ritratti, rilievi in marmo, sarcofagi e urne, mosaici pavimentali e decorazioni pittoriche parietali, e ancora preziosi argenti da mensa, elementi architettonici figurati e altari permettono di apprezzare da vicino il gusto di un’intera epoca, di riflettere sui cambiamenti formali e sui temi figurativi presentati da oggetti che decoravano gli spazi urbani e quelli privati (case e tombe). La prima sezione, I protagonisti, con circa 92 opere, è una ricca presentazione di ritratti, statue e busti degli imperatori regnanti e delle loro mogli, e anche dei cittadini più abbienti dell’epoca; la seconda sezione L’esercito presenta, con oltre 20 opere, l’esercito come uno dei grandi protagonisti della nuova epoca, capace di un enorme potere, perfino di imporre o eliminare imperatori a lui sgraditi; la terza sezione dedicata a La città di Roma, con 14 opere, racconta i grandi cambiamenti che nel III secolo segnano profondamente la città di Roma nella sua identità, dalla costruzione del circuito murario che prenderà il nome di “Mura Aureliane” (e che tuttora segna il paesaggio urbano della città), alla presenza di grandi caserme militari, alla realizzazione di una pianta marmorea della città su grande scala (cosiddetta Forma Urbis Severiana); la quarta sezione La religione, attraverso 52 opere, ci riporta un fenomeno di grande portata ovvero l’arrivo in città di culti orientali, e che si andranno ad affiancare piano piano ai culti tradizionali celebrati fino a quel momento: Iuppiter Dolichenus, Mitra, Helios-Sol, Sabazio, Cibele/Attis, Iside saranno capaci di attrarre una gran massa di fedeli, e di rispondere ad alcune delle esigenze che porteranno in breve all’affermazione straordinaria del Cristianesimo; la quinta sezione Le ricche dimore private e i loro arredi, con circa 30 opere, offre uno sguardo sugli spazi privati, sui gusti e gli arredi domestici di alcune delle più ricche dimore private dell’epoca; la sesta sezione Vivere (e morire) nell’Impero, circa 7 opere, racconta i cittadini romani al di fuori della Capitale: i loro gusti, le loro attività quotidiane, le loro immagini funerarie; la settima sezione I costumi funerari composta di 24 opere: sarcofagi, rilievi e pitture con una ricca presentazione di temi e soggetti, tratti dai repertori dei miti tradizionali e innovati secondo linguaggi e gusti ormai del tutto differenti.
Sintomatico di questo mal di vivere, di questa angoscia del quotidiano è una lettera che nel 251 d.c., il vescovo di Cartagine Cipriano scrive a Demetriano, nemico dei cristiani, da lui accusati di essere responsabili delle guerre, delle pestilenze, delle carestie e di ogni sorta di avversità. «Dalle montagne escavate ed esplorate – scrive Cipriano – non si estrae più con la stessa abbondanza la lastra marmorea; le miniere ormai sono esauste, offrono minor ricchezza d’argento e d’oro e i loro filoni vanno man mano scomparendo […] scompare l’integrità nel foro, la giustizia nei giudizi, la concordia tra gli amici, l’abilità nelle arti, la disciplina nei costumi […]. necessariamente declina ogni cosa che, avvicinandosi ormai alla sua fine, vien meno e precipita». E nella tarda repubblica si assiste a una lotta senza quartiere tra comandanti di eserciti che erano anche influenti magistrati, e le loro fazioni. Secondo l’opinione pubblica corrente, Roma sembrava destinata a crollare miseramente sotto il peso di tante scelleratezze. Si vagheggiava la rovina di Roma, il crollo di città fiorenti e ricche d’oro e d’argento, ma si faceva strada anche la speranza per l’avvio di una nuova età dell’oro, e la nascita di un uomo (un uomo simile a un dio, quasi certamente Ottaviano) che avesse la capacità di riportare ordine e pace sulla terra.
Ma a questa visione nichilista non si associa Eugenio La Rocca uno dei tre curatori della mostra che nel suo saggio L’età dell’Angoscia, forse dell’ambizione pubblicato nel ricco catalogo osserva: «A volte si dimentica che, malgrado tutte le difficoltà, l’Impero seppe resistere bene alle trasformazioni in atto, sia in età tardo-repubblicana sia nel III secolo d.C.; l’esercito si dimostrò uno strumento efficace contro i nemici, contro le troppo frequenti pressioni barbariche lungo i confini, perfino contro, o a favore dei suoi generali, la cui ambizione era quella di ascendere al soglio imperiale, anche a costo della propria vita, come del resto normalmente avvenne (cfr. il saggio di Alexandra Busch sull’esercito a Roma). Non è casuale che Peter Brown abbia considerato il III secolo d.C. più un’età dell’ambizione che non un’età dell’angoscia, all’unisono con quella “manifestazione di volontà di potenza” di cui aveva già parlato Ranuccio Bianchi Bandinelli. Non si è forse tenuto nel dovuto conto chela maggior parte degli imperatori del III secolo d.C., provenienti dai ranghi militari, erano eccellenti comandanti, capaci di far fronte ai pericoli di invasioni. D’altronde, l’Impero ebbe ancora una lunga vita, ben superiore a quanto potesse far presupporre, secondo la lettura tradizionale, un’età dominata dall’angoscia. È vero che la ricchezza si concentrò in poche mani, e che fu ostentata in forme differenti rispetto al II secolo d.C.: in primo luogo con una magnificenza dell’edilizia privata, che gli scavi degli ultimi decenni documentano in modo sempre più preciso (cfr. il saggio di Laura Buccino sull’edilizia privata, specialmente a Roma), con un lusso dei monumenti funerari (basti pensare al sarcofago Ludovisi; cfr. il saggio di Stefano Tortorella sui costumi funerari prevalentemente a Roma), e con uno sfarzo di vita fino allora impensabile. Ma tutto sommato il sistema tenne, e la vita nei principali centri urbani si adeguò rapidamente alle nuove situazioni. Quel che effettivamente avvenne fu un mutamento radicale ma non repentino, nei rapporti dello stato e dei sudditi con la religione tradizionale, e nelle forme di autorappresentazione imperiale».
Sostituiamo la parola religione con politica o istituzioni e, volendo, si potrà uscire da questa mostra con un pensiero cautamente positivo sui tempi che ci aspettano…

 La «Retorica» di Aristotele: una tecnica per convincere un uditorio con buone ragioni ma evitando di scadere nella demagogia. Ecco perché dovrebbe essere un riferimento nella formazione del buon cittadino
La «Retorica» di Aristotele: una tecnica per convincere un uditorio con buone ragioni ma evitando di scadere nella demagogia. Ecco perché dovrebbe essere un riferimento nella formazione del buon cittadino