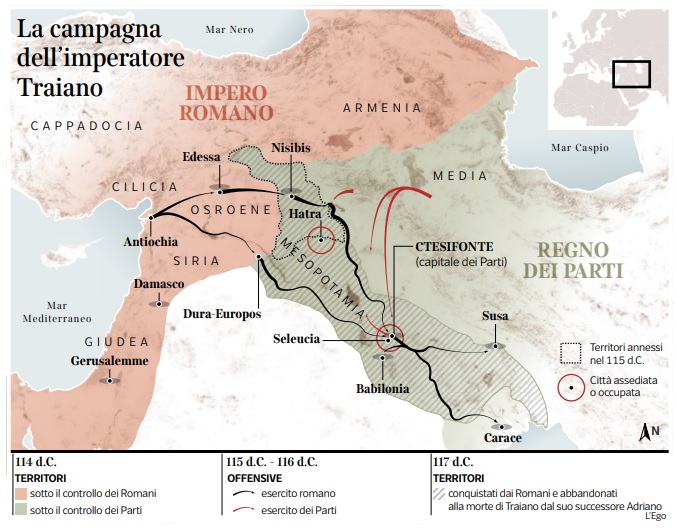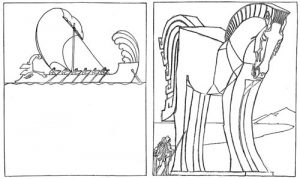Gli scrittori latini nel giudizio di Des Esseintes, protagonista del romanzo di J. K. Huysmans À rebours [Controcorrente], pubblicato nel 1884.
Parte delle scansie che rivestivano le pareti dello studio blu e arancio, erano riservate a quella letteratura latina che i cervelli mortificati dalle Sorbone, pappagallescamente designano sotto il nome generico: «la decadenza».
Ché il latino, come lo si scrisse nel secolo che i professori si ostinano tuttora a chiamare il secolo d’oro, non lo attirava granché. Quella lingua ristretta, dai giri di frasi contati, pressoché invariabili; irrigidita nella sua sintassi, senza colore né sfumature; quella lingua lisa in ogni costura, accuratamente potata delle espressioni meno corrette ma a volte quanto mai efficaci delle età precedenti; poteva a rigore enunciare le pompose banalità, i vaghi luoghi comuni che rimasticavano retori e poeti; ma emanava un tale disinteresse, un tale tedio che per trovare un’altra lingua altrettanto mortificata di proposito, altrettanto solennemente grigia e massacrante, il filologo doveva scendere sino allo stile francese del secolo di Luigi XIV.
Fra tutti, l’ineffabile Virgilio, colui che i prefetti di camerata chiamano il cigno di Mantova – evidentemente perché non è nato in tale città – gli appariva non solo uno dei più esosi pedanti, ma anche uno dei più sinistri rompiscatole che l’antichità abbia mai prodotto. I suoi pastori, usciti pur mo’ dal bagno ed azzimati di tutto punto, che si scaricano a vicenda sul capo filastrocche di versi sentenziosi e gelati; il suo Orfeo ch’egli paragona a un usignolo in lagrime; il suo Aristeo che piagnucola per delle api; il suo Enea, questo personaggio indeciso e ondeggiante che si muove come un’ombra cinese, con mosse di marionetta, dietro il trasparente malfermo e male oliato del poema, lo mettevano fuori dei gangheri.
E ancora, egli sarebbe passato sopra alle noiose scemenze che quei burattini si scambiano a vuoto; avrebbe chiuso un occhio sugli impudenti plagi di cui fan le spese Omero, Teocrito, Ennio, Lucrezio; sul furto bell’e buono, di cui ci informa Macrobio, costituito dal secondo libro dell’Eneide, copiato si può dire parola per parola da un poema di Pisandro; su tutta insomma la indicibile vuotaggine di quel centone di canti; ma ciò cui non poteva passar sopra era la fattura di quegli esametri che rendon suono di latta, di fiasca di latta vuota; che alternano le lunghe e le brevi di parole pesate a chilo secondo l’immutabile schema d’una prosodia arida e pedante; l’ordito di quei versi rasposi e burbanzosi, nella loro tenuta ufficiale, nella loro bassa soggezione alla grammatica; di quei versi meccanicamente spezzati da un’impassibile cesura, turati in coda sempre allo stesso modo dall’inciampare d’un dattilo in uno spondeo.
Tolta in prestito alla perfezionata officina di Catullo, quella invariabile metrica, senza fantasia, senza discrezione, impinzata di parole inutili, di zeppe, di appigli sempre eguali e previsti; quella miseria dell’epiteto omerico che torna ogni momento e non dice nulla, non evoca nulla; tutto quell’indigente vocabolario sordo e piatto, lo mettevano alla tortura.
Ma se la sua ammirazione per Virgilio era delle meno calorose e dei più modesti e sordi il fascino che esercitavano su lui le evidenti cacate di Ovidio, una sconfinata avversione provava per le grazie elefantesche di Orazio, per il balbettìo di questo insopportabile centochili che fa lo smorfioso con lazzi di vecchio saltimbanco infarinato.
Nella prosa la verbosità, le ridondanti metafore, le gratuite disgressioni del Cece, non lo allettavano di più. La jattanza delle sue apostrofi, l’alluvione di luoghi comuni patriottici, l’enfasi delle sue concioni, la greve compattezza del suo stile carnoso, ben nutrito ma degenerato in grasso, privo d’osso e di midolla; le intollerabili scorie degli avverbi sesquipedali coi quali apre le frasi, l’inalterabile schema su cui son calcati i suoi adiposi periodi, mal cuciti insieme dal filo delle congiunzioni; infine il tedioso vezzo della tautologia, lo seducevano mediocremente. Né molto di più di Cicerone lo entusiasmava Cesare, famoso pel suo laconismo; perché l’eccesso contrario diventava in questo aridità da caporalmaggiore, secchezza da appunto, stitichezza incredibile e sconveniente.
Tirate le somme, non trovava di che pascersi né in questi né in quegli altri scrittori che pure fan la delizia dei falsi letterati: Sallustio, ancorché meno sbiadito degli altri; Tito Livio, patetico e pomposo; Seneca, turgido e scialbo; Svetonio, linfatico ed embrionale; Tacito, il più nerboruto tuttavia nella sua voluta concisione, il più aspro, il più muscoloso di tutti costoro.
In poesia, lo lasciavano freddo Giovenale, nonostante qualche verso ben battuto; quanto Persio, nonostante le sue oscure allusioni. Trascurando Tibullo e Properzio, Quintiliano e i due Plinio, Stazio, Marziale di Bilbili, lo stesso Terenzio e Plauto (di Plauto gli sarebbe piaciuto il gergo pieno di neologismi, di parole composte, di diminutivi; ma lo torturava la sua comicità plebea, il suo sale grosso di cucina); Des Esseintes cominciava ad interessarsi con Lucano. Con Lucano il latino si liberava delle sue pastoie, diventava meno mortificato, più espressivo. Quell’armatura cesellata, quei versi smaltati, ingioiellati se lo cattivavano; ma la preoccupazione esclusiva della forma, quelle sonorità verbali, quegli squilli di metallo non riuscivano a celargli del tutto il vuoto del pensiero, le ampollosità che seminano di tumori la superficie della Farsalia.
L’autore che amava davvero, che gli faceva bandire per sempre dalle sue letture le roboanti tirate di Lucano, era Petronio.
Eccolo finalmente un acuto osservatore, un fine analista, un pittore meraviglioso. Tranquillamente, senza partito preso, senza animosità di sorta, Petronio descriveva la vita d’ogni giorno a Roma, fermava nei vivaci corti capitoli del Satyricon i costumi del tempo.
Annotando via via i fatti, consegnandoli in una forma definitiva, egli faceva passare sotto gli occhi del lettore la minuta vita del popolo con le sue peripezie, le sue bestialità, le sue foie.
Qui è l’ispettore alle locande che viene a chiedere il nome dei viaggiatori ultimi arrivati. Là, lupanari dove i clienti girano intorno a donne nude che si esibiscono in piedi tra cartelli; mentre per gli usci mal chiusi delle stanze si intravedono coppie sollazzarsi. Là ancora, in ville d’un lusso sfacciato, d’una ricchezza e d’un fasto pazzeschi, o in miserabili taverne che si susseguono coi vivai di piattole dei loro giacigli a cinghia disfatti, s’agita la società del suo tempo. Osceni marioli, quali Ascilto ed Eumolpo, in busca d’una buona bazza; vecchi sporcaccioni dalla veste rimboccata, le guance intonacate di cerussa e rossetto; gitoni sedicenni, paffuti e riccioluti; donne in preda ad attacchi isterici; genitori a caccia di eredità nell’atto di offrire figli e figlie alle voglie dei testatori; tutti passano schizzati nelle pagine, si vedono discorrere per le vie, palpeggiarsi nei bagni, caricarsi di botte come in una pantomima.
E tutto questo, raccontato in uno stile d’un colorato preciso, d’un brio indiavolato; in una lingua che attinge a tutti i dialetti, toglie in prestito modi di dire a tutti gli idiomi portati a spasso per Roma; in una sintassi che non conosce barriere, sciolta dalle pastoie del cosidetto secolo d’oro, e che fa parlare a ciascuno il suo idioma: ai rozzi liberti, il latino plebeo, il gergo della strada; agli stranieri il loro dialetto barbarico, imbastardito d’africano, di sirio e di greco; ai pedanti imbecilli, come l’Agamennone del libro, un retoricume di parole posticce. Tutti questi personaggi sono schizzati d’un solo tratto di penna, mentre, abbruttiti intorno ad una tavola, scambiano sceme frasi da ubbriachi, spacciano massime barboge, insulsi proverbi, il grugno volto verso Trimalcione che si stuzzica i denti, offre orinali ai convitati, li intrattiene sullo stato del suo ventre e dei suoi intestini, li invita a mettersi a lor agio.
Questo romanzo verista, questa fetta di vita romana tagliata nel vivo, che non si preoccupa, checché si dica, né di riformare né di satireggiare i costumi; che fa a meno d’una conclusione e d’una morale; questa storia senza intreccio, dove non succede nulla, che mette in scena le avventure della selvaggina di Sodoma; che analizza con imperturbabile acutezza gioie e dolori di codesti amori e di codeste coppie; che, senza che l’autore faccia mai capolino, senza che si lasci andare a un solo commento, senza che approvi o maledica gli atti o i pensieri dei suoi personaggi, dipinge in una lingua da orafo i vizi d’una civiltà decrepita, d’un impero che si va sfasciando – conquideva Des Esseintes, il quale nella raffinatezza dello stile, nell’acutezza dell’osservazione, nel fermo piglio con cui la narrazione veniva condotta, intravvedeva singolari parentele, curiose analogie con i pochi romanzi del tempo suo che non gli dispiacevano.
Inutile aggiungere ch’egli rimpiangeva amaramente l’irrimediabile perdita delle altre due opere di Petronio, menzionate da Planciade Fulgenzio; l’Eustion e l’Albutia; ma di quella perdita consolava il letterato il bibliofilo che era in lui, e che del Satyricon poteva religiosamente maneggiare la splendida edizione di sua proprietà: l’in-ottavo, recante il millesimo 1585 e il nome di J. Dousa, stampatore a Leyda.
A partire da Petronio, s’entrava nel secondo secolo dell’era cristiana.
La collezione saltava Frontone, il declamatore dal vocabolario antiquato, malamente rabberciato e rinverniciato; scavalcava le Notti attiche di Aulo Gellio, discepolo di Frontone e amico suo: mente sagace e indagatrice, ma, come scrittore, impegolato in una melma attaccaticcia; e sostava davanti ad Apuleio, presentato nell’edizione principe, in-folio, stampata a Roma nel 1469.
Questo africano gli richiamava in volto il sorriso.
Nelle sue Metamorfosi il latino raggiungeva la pienezza: travolgeva seco limi, acque diverse, affluite da tutte le provincie; e tutte si mescevano, si confondevano in una tinta bizzarra, esotica, quasi nuova. Vezzi, particolari nuovi della società latina trovavano la loro piena espressione in neologismi scaturiti, in quell’angolo d’Africa romano, dalle necessità della conversazione.
Inoltre lo divertiva quella sua esuberanza d’uomo evidentemente pingue, quella sua esuberanza meridionale. Apuleio gli appariva così come un gaio e salace mattacchione vicino agli apologisti cristiani che fiorivano nello stesso suo secolo: il soporifero Minucio Felice, un falso classico che spaccia nel suo Octavius le emulsioni, inspessite ancora, di Cicerone; nonché lo stesso Tertulliano, che probabilmente Des Esseintes conservava più per l’edizione aldina che per l’opera in sé.
Sebbene fosse ferrato in teologia, le dispute dei montanisti contro la Chiesa cattolica, le polemiche sulla gnosi, lo lasciavano freddo; dimodoché, sebbene di Tertulliano lo interessasse lo stile – uno stile conciso, pieno di anfibologie, che si regge sui participi, scoppietta di antitesi, gremito di giochi di parole e di frizzi, screziato di vocaboli pescati nel giure e nella lingua dei Padri della Chiesa – non apriva quasi più l’Apologetico né il Trattato sulla Pazienza; tutt’al più scorreva qualche pagina di quel De cultu feminarum dove l’autore scongiura le donne di non pararsi di gioielli e di stoffe preziose ed interdice loro l’uso dei cosmetici perché s’arrogano di emendare la natura e di abbellirla.
Queste idee, diametralmente opposte alle sue, lo facevano sorridere. Aggiungi che la parte sostenuta da Tertulliano come vescovo di Cartagine, gli pareva dar materia a divertenti riflessioni. Più dell’opera, era l’uomo che lo attirava.
Sebbene infatti vivesse in tempi procellosi, agitati da paurosi torbidi, sotto Caracalla, sotto Macrino, sotto lo stupefacente Pontefice di Emesa, Elagabal, egli preparava imperterrito i suoi sermoni, gli scritti di dogmatica, le difese, le omelie, intanto che l’impero romano vacillava dalle fondamenta, mentre le follie dell’Asia, le sozzure del paganesimo scorrevano come fiume in piena. Raccomandava con la maggiore serietà l’astinenza carnale, la frugalità nel cibo, la modestia nel vestire, mentre, incedendo su polvere d’argento e sabbia d’oro, cinto di tiara il capo, i paludamenti tempestati di gemme, Elagabal accudiva nel cerchio dei suoi eunuchi a lavori donneschi; si faceva chiamare Imperatrice e mutava ogni notte di Imperatore, eleggendoselo di preferenza tra i barbitonsori, i rovinasalse ed i cocchieri di circo.
Questo contrasto estasiava Des Esseintes. Aggiungi che il latino, giunto con Petronio all’apice della perfezione, cominciava a corrompersi; la letteratura cristiana, imponendosi, introduceva con le nuove idee nuove parole, costrutti inusitati, verbi sconosciuti, aggettivi di senso lambiccato, vocaboli astratti: rari sin allora nella lingua romana, e che Tertulliano era stato il primo ad adottare.
Senonché questo processo di deliquescenza, proseguito dopo la morte di Tertulliano dal suo discepolo San Cipriano, da Arnobio, dal pesante e goffo Lattanzio, era senza attrattiva. Era un infrollirsi lento e parziale con sgraziati ritorni all’enfasi ciceroniana; cui mancava ancor quel particolare sentore che nel IV secolo e soprattutto nei secoli che gli seguiranno il cristianesimo comunicherà alla lingua pagana, ormai corrotta come selvaggina; e che si sbriciolerà via via che s’andrà sgretolando la civiltà del vecchio mondo, via via che crolleranno sotto l’urto dei Barbari gli Imperi putrefatti dalla sanie dei secoli.
Un solo poeta cristiano, Commodiano di Gaza, rappresentava nella biblioteca l’arte del terzo secolo. Il suo Carmen apologeticum, scritto nel 259, è una raccolta di precetti, torti in acrostico, composto in esametri popolareschi messi insieme senza badare alla quantità e lo hiatus ed accompagnati sovente di rime; di quelle rime di cui il latino chiesastico darà in seguito numerosi esempi.
Quei versi stentati, cupi, che san di selvatico, pieni di termini della parlata, di vocaboli distratti dal loro primiero significato, lo attiravano, lo interessavano anche più dello stile mézzo e già frollo degli storici Ammiano Marcellino e Aurelio Vittore, dell’epistolografo Simmaco e del compilatore e grammatico Macrobio; sinanco li preferiva agli autentici versi scanditi, alla lingua screziata e superba che parlarono Claudiano, Rutilio e Ausonio.
Eran questi allora i maestri, i cui gridi riempivano l’Impero agonizzante: il cristiano Ausonio, col suo Centone Nuziale e coll’esuberante e fastoso poema La Mosella; Rutilio, coi suoi inni alla gloria di Roma, gli anatemi contro monaci e giudei, col suo viaggio dall’Italia alla Gallia in cui riesce a rendere mirabilmente certe sensazioni ottiche: l’incertezza dei paesaggi riflessi nell’acqua, le morgane che crea il vapor acqueo, lo staccarsi dai monti e l’involarsi del nebbione che li avviluppava; Claudiano, una specie di reincarnazione di Lucano, che domina tutto il quarto secolo col clangore guerriero dei suoi versi; il fabbro d’un esametro smagliante e sonoro che tra un grande sprizzar di faville foggia d’un colpo di martello l’epiteto, animando l’opera d’un afflato possente, attingendo una specie di grandezza.
Nell’Impero d’Occidente, che sempre più si va sfasciando, nel cruento pantano dei massacri che si susseguono incessanti intorno a lui, nella perenne minaccia dei Barbari che si pigiano ormai in folla alle porte dell’Impero e ne fan scricchiolare i cardini, Claudiano resuscita l’antichità, canta il ratto di Proserpina, sfida il tempo con lo smagliare dei suoi colori, passa con tutti i suoi fuochi accesi nel buio che inghiotte il mondo.
Torna con lui il paganesimo a suonare la sua ultima fanfara; alza in lui il suo ultimo grande poeta al disopra del Cristianesimo, che sommergerà d’ora in poi completamente la lingua e che, per sempre ormai, resterà unico maestro d’arte: con Paolino, allievo d’Ausonio; col prete spagnolo Juvenco che parafrasa in versi l’Evangelo; con Vittorino, l’autore dei Maccabei; Sanctus Burdigalensis che in un’ecloga, imitata da Virgilio, fa lamentare ai pastori Egone e Bucolo le malattie dei loro greggi; con tutta la serie dei Santi: Ilario di Poitiers, il difensore della fede di Nicea, l’Atanasio dell’Occidente come vien chiamato; Ambrogio, autore d’indigeste omelie, tedioso Cicerone cristiano; Damaso, il fabbricante di epigrammi lapidari; Gerolamo, il traduttore della Vulgata ed il suo avversario Vigilanzio di Comminges, che se la prende col culto dei santi, l’abuso dei miracoli, i digiuni; e che già predica, con argomenti che i secoli riprenderanno da lui, contro i voti monastici ed il celibato dei preti.
Infine, nel quinto secolo, Agostino, vescovo di Ippona.
Questo, Des Esseintes non lo conosceva che troppo: non era lo scrittore più apprezzato della Chiesa, il fondatore dell’ortodossia cristiana, colui che i cattolici tengono in conto di oracolo, di maestro dei maestri?
Sicché non lo apriva più, sebbene nelle Confessioni avesse cantato il fastidio del mondo e sebbene nella Città di Dio la sua gemebonda devozione avesse cercato d’alleviare con la cullante prospettiva di destini migliori la paurosa angoscia del tempo. Bazzicava ancora la teologia, che già Des Esseintes era ristucco delle sue prediche e geremiadi, delle sue teorie sulla predestinazione e sulla grazia, delle sue polemiche contro gli Scismi.
Preferiva sfogliare la Psychomachia di Prudenzio, l’inventore del poema allegorico che doveva poi imperversare nel Medio Evo; e l’opera di Sidonio Apollinare, l’autore di quelle lettere che lo attiravano, lardellate com’erano di arguzie, di frecciate, d’arcaismi, di indovinelli. Con diletto si rileggeva i panegirici dove questo vescovo per dar forza ai suoi vanitosi encomi, invoca le deità pagane; e, nonostante tutto, sentiva un debole per le affettazioni ed i sottintesi di quelle poesie, opera d’un ingegnoso operaio che ha cura della sua macchina, ne olia gli ingranaggi, ne inventa all’occorrenza di complicati e di inutili.
Dopo Sidonio, bazzicava ancora il panegirista Merobaude; Sedulio, autore di poemi rimati e d’inni abbecedari, di cui la Chiesa s’appropriò certe parti per i bisogni dei suoi offizi; Mario Vittore il cui tenebroso trattato sulla Pravità dei costumi s’illumina qua e là di slucciolii fosforescenti; Paolino di Pella, il poeta dell’infreddolito Eucharisticon; Orienzio, vescovo di Auch, che nei distici dei suoi Monitori scoppia in invettive contro la dissolutezza delle donne che col loro viso, afferma, mandano i popoli alla perdizione.
L’interesse che Des Esseintes portava alla lingua latina, non s’affievoliva neanche ora che, completamente putrefatta, essa penzolava, perdendo membro a membro, colando marcia; neanche ora che da tanta corruzione restavano illese poche parti che gli scrittori cristiani staccavan via per marinarle nella salamoja della loro nuova lingua.
La seconda metà del quinto secolo era venuta; l’epoca spaventosa in cui la terra sembrò vacillare sulle sue fondamenta. I Barbari saccheggiavano la Gallia; Roma paralizzata, messa a ferro e fuoco dai Visigoti, avvertiva il gelo della fine; vedeva le sue più lontane provincie, l’Oriente e l’Occidente, dibattersi nel sangue, ogni giorno più esaurirsi.
In mezzo allo sfacelo generale, mentre uno dopo l’altro i Cesari cadevano assassinati, fra gli urli che s’alzavano dalle carneficine di cui l’Europa da un capo all’altro s’insanguinava, più forte d’ogni voce, dominando ogni clamore, un urrà raccapricciante echeggiò. Sulla riva del Danubio, migliaia d’uomini, piantati su piccoli cavalli, avviluppati in casacche fatte di pelli di topo, dei Tartari orrendi, con enormi teste, nasi schiacciati, menti scavati da sfregi e cicatrici, glabre facce di itterici, si precipitano ventre a terra, circondano d’un turbine le terre dei Bassi Imperi.
Tutto sparì nella polvere che il loro galoppo sollevava, nel fumo degli incendi. La notte si fece; ed i popoli interroriti tremarono udendo passare col rombo d’un tuono il ciclone devastatore. L’orda degli Unni spianò l’Europa, irruppe nella Gallia, dove nelle piane di Châlons Ezio la macellò in una memorabile carica. La pianura, imbevuta di sangue, schiumò come un mare di porpora. Duecentomila cadaveri, sbarrando la strada, infransero l’impeto di quella valanga, che, deviata, precipitò con schianti di folgore sull’Italia, dove le città messe a sacco arsero come mucchi di fieno.
All’urto, l’Impero d’Occidente crollò; la vita di moribondo che trascinava nell’imbecillità e nel lordume si spense. La fine del mondo pareva del resto vicina: le città risparmiate da Attila, le decimava la fame e la peste. Il latino sembrò restar schiacciato pur lui sotto le macerie del mondo.