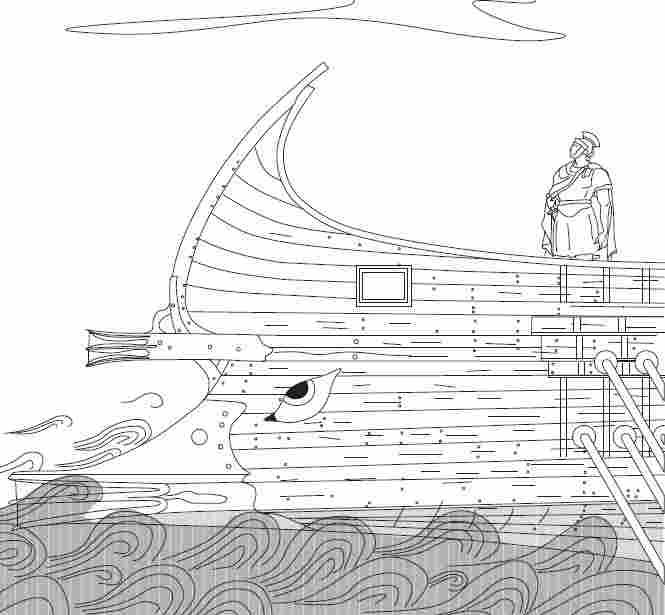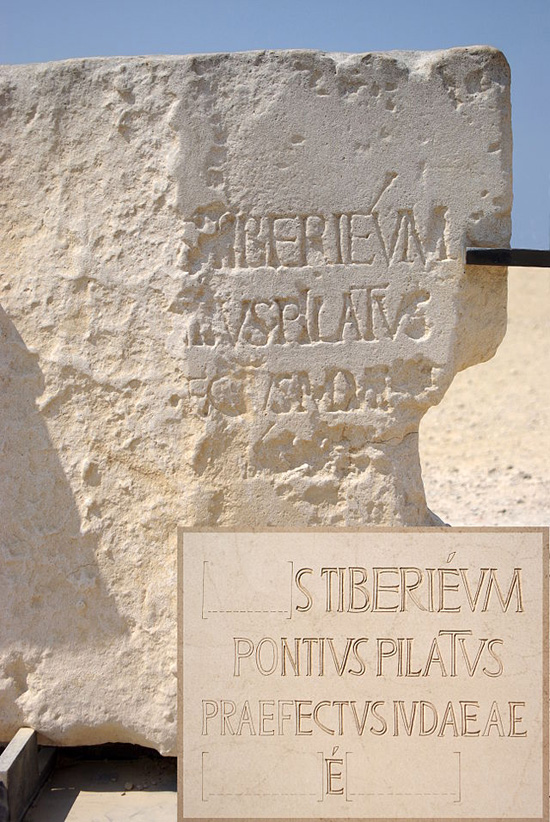Nei comportamenti degli eroi omerici c’è l’anima dell’Occidente: dal potere (Agamennone) alla pietà per il nemico (Priamo/Achille)
Intervista a Giulio Guidorizzi di Maurizio Assalto,
“La Stampa – Tuttolibri”, 26 giugno 2016
«Sono stato preso dal gran fiume di Omero. Come una barchetta che segue la corrente». E seguendo la corrente, nel suo Io, Agamennone, Giulio Guidorizzi, professore di Letteratura greca all’Università di Torino, intrepido navigatore nel mare magnum del mito, ha riscritto la storia della guerra di Troia, dal punto di vista del signore di Micene, e sviluppando tutti quei punti che nell’Iliade sono lasciati in sospeso. «La mia idea iniziale era di scrivere un’introduzione a Omero per il pubblico ampio, che contenesse gli elementi della sua antropologia. Quindi ho concepito un po’ follemente un saggio-racconto, che via via è diventato più racconto che saggio». Il gran fiume del cantore cieco, appunto. «Ho usato un linguaggio paratattico, frasi brevi, frequenti divagazioni – proprio come lui – per cercare di riproporre il tessuto orale della sua poesia. E così sono diventato un piccolo piccolissimo Omero. Un rapsodo».
Agamennone non è un personaggio molto simpatico: perché ha incentrato il suo racconto su di lui?
«Per alcune ragioni. Perché offre un panorama completo di tutta la guerra di Troia – mentre Achille muore, Ettore muore… Poi perché rappresenta la prospettiva della regalità: è quello che dall’alto della gerarchia sociale osserva ed è però anche attore dell’azione. E infine proprio perché è un personaggio antipatico ai più: e invece leggendo l’Iliade ci si rende conto che ha uno spessore psicologico».
Cioè?
«In apparenza è arrogante, borioso, pretende di governare il destino degli altri. Però ci sono degli squarci in cui appare un’altra persona, che palpita per il fratello ferito, si prende cura della comunità, sa anche ammettere le sue colpe. Come tutti gli eroi ha due facce: una scura e una luminosa. Perché Omero non è soltanto un narratore epico che racconta una storia: è anche capace di far venire fuori l’interiorità dei suoi personaggi. E nessuno è uguale agli altri».
Oltre a Omero, e ovviamente all’Agamennone di Eschilo, di quali fonti si è servito?
«Ho usato le mie letture, che mi hanno aiutato a dare colore ai personaggi. Per esempio c’è un briciolo di Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, nell’impianto mitico, nel modo di narrare. C’è anche qualcosa di Tolstoj: quando racconto l’innamoramento di Elena, il colpo di fulmine all’arrivo di Paride, dico che lei – senza ancora avvedersi che le sta nascendo dentro la passione, a cui non può opporsi, perché è stata prescelta da Afrodite – si accorge per la prima volta che suo marito Menelao ha alcuni fili bianchi nella barba e ride troppo forte: come Anna Karenina, quando arriva alla stazione dopo che Vronskij le ha rivelato il suo amore e si accorge che il marito ha delle orecchie strane – da un dettaglio insignificante, il primo accenno del disamore».
Una volta nei banchi di scuola ci si divideva tra fan dell’Iliade e fan dell’Odissea: lei a quale partito appartiene?
«Al primo. Perché l’Iliade dà un quadro sublime di una società eroica, contiene tutto il modo di essere e il modo di pensare di una società guerriera in cui, è vero, ognuno combatte con l’altro, ma in realtà ognuno combatte contro il suo destino».
Non le pare tuttavia che l’Odissea, in quanto racconta un mondo «fluido», privo di riferimenti stabili, in cui l’eroe deve di continuo mettere alla prova la propria capacità di far fronte agli imprevisti, possa parlare di più all’uomo contemporaneo?
«La mia sfida è far parlare all’uomo contemporaneo anche l’Iliade, far capire che dietro a questa crudeltà inesorabile c’è una visione alta, disperata dell’esistenza, che è molto vicina a noi. L’Iliade parla di quel blocco di emozioni, passioni e forze che si agitano nell’anima umana – la sfida, la morte, l’amore -, forze possenti contro cui tu puoi solo opporre la tua volontà, ma sapendo che ne sarai travolto. L’Odissea ci mette a contatto con un modello di uomo che ci è lontano, perché vive in un mondo favoloso, ma al tempo stesso vicino, perché il soggetto umano è già circoscritto, c’è un io. L’io dei personaggi dell’Iliade non è così: è un io dilatato dalla volontà di autoaffermarsi, dalle passioni e da questo senso veramente tragico, la consapevolezza che la vita inizia e finisce, come spazio di luce, tra due eternità di buio. Cioè, la radice della tragedia è nell’Iliade, come sapeva Aristotele. L’Odissea è più vicina al romanzo».
Qual è il suo eroe preferito?
«Mah, direi tutti. Io convivo con questi personaggi da cinquant’anni ed è come se li sentissi miei amici. Ognuno ha la sua risposta da dare di fronte alla moîra, al destino che sfugge al controllo umano, e ognuno lotta con la propria sorte istante per istante come se fosse l’ultimo momento della sua vita. È un mondo che non conosce trascendenza, perché la morte spazza via tutto, ogni cosa si gioca qui e ora. E questi eroi mostrano – ognuno a suo modo – che non possono sfuggire al destino, nessuno può».
Un episodio memorabile?
«Uno su tutti: l’incontro di Priamo e Achille. Qualcosa di meraviglioso: riconoscere sé stesso in un nemico. Ciò che li accomuna è la pietà, perché ognuno comprende nell’altro il proprio dolore. Io credo che pochi passi nella letteratura mondiale siano più commoventi di quello in cui questi due personaggi si abbracciano, ognuno nel proprio dolore, e Achille vede in quel vecchio il proprio padre, e Priamo riconosce nel dolore di Achille la sua stessa perdita. Le loro lacrime si mescolano: solo Omero può usare un’immagine così bella, così forte. È un passo quasi filosofico, dove si raggiunge la consapevolezza dell’appartenenza a un destino comune, in cui tutti gli uomini si costituiscono come tali in contrapposizione agli dèi, e hanno la dignità e l’orgoglio della propria sofferenza».
Dopo avere riscritto l’lIiade, ora lei si appresta a curarne una nuova edizione in sei volumi, per la Fondazione Valla, a capo di un’équipe internazionale. Ci saranno problemi di traduzione?
«Tanti. A partire dalle espressioni formulari, che una volta i traduttori tendevano a stemperare, ma che sono state opportunamente reintrodotte da Rosa Calzecchi Onesti, per me la più grande traduttrice di Iliade e Odissea. Poi c’è il fatto che tanti concetti omerici non hanno una precisa corrispondenza nel sistema semantico italiano, e quindi occorre fornire una versione – come dire? – antropologica, che cerchi di mantenere lo splendore dei versi ma anche di dare l’idea di un mondo culturalmente altro. Per esempio, psyché non è solo l’anima, è la vita, certe volte è il soffio, l’ultimo respiro. E poi vorrei che alcuni termini fossero resi mantenendo il suono meraviglioso della lingua greca. Speriamo che gli dèi ci aiutino: Atena, soprattutto, ma anche gli altri».